Siamo soliti affermare che le religioni monoteiste siano tre, Cristianesimo, Ebraismo e Islamismo, poiché in queste forme di culto la divinità si manifesta come entità “unica” suprema. Viceversa, dato che nell’Induismo sono presenti molte entità dalle connotazioni divine, siamo portati a pensare che sia un culto di tipo politeistico*, facendo sovente riferimento al pantheon greco-latino. Questa visione rischia di essere una eccessiva riduzione di complessità.
Nella concezione che ogni cultura ha di sé, si trova sempre una vena di superiorità quasi antropologica che, unita alle proprie conquiste in ambito economico, politico, sociale e insieme alla naturale propensione di ogni religione a considerarsi l’unica vera forma di verità, porta inevitabilmente a sottovalutare e ridurre il reale e complesso sistema che compone culture e religioni anche più antiche della nostra. Innanzi tutto siamo abituati alle forme in cui il potere civile e religioso si sono connaturati nella nostra storia, dando luogo ad un’unica autorità religiosa che è il Pontefice con sede in Vaticano.

In India non esiste un’autorità religiosa centrale, cui viene riconosciuto il ruolo di istituzione per il controllo del culto, con un sistema gerarchico di potere che determina le forme del rito liturgico e depositario esclusivo delle versioni autorizzate delle scritture. Questo elemento non da poco, ci fornisce l’idea di come spiritualità e religione rivestano due ruoli separati e conducano a finalità che, per quanto incomprensibilmente per noi, nella storia dell’Induismo hanno caratterizzato sul piano filosofico e culturale la società indiana. Certamente anche in India, sotto il profilo storico, si è caratterizzata una fase chiamata periodo brahmanico che dal II millennio a.C. alla metà del I millennio d.C., ha determinato una predominante religiosa, con l’affermazione anche delle caste, che è stata centrale nella società e nella cultura.
Tuttavia, il sistema di pensiero su cui si fonda il sapere vedico e tutta la filosofia vedica indiana, è centrato sul concetto di parampara, la linea di successione discepolare che trasmette il sentimento, il sapere,
l’attitudine interiore da Maestro a discepolo in una linea temporale che, nell’epica vedica, si fa risalire direttamente a Dio e alle sue manifestazioni. In questo contesto sono sempre esistite le diverse scuole di pensiero e tradizioni che hanno contribuito notevolmente all’elaborazione di un articolato sistema di concezioni che descrivono la natura della Verità Assoluta, divenuta nel tempo patrimonio dei Brahmana e degli adepti di Yoga.
Per ciò che concerne la filosofia indiana, l’elemento razionale scientifico non è centrale come per la nostra formazione culturale. Il pensiero, l’intelletto, la mente, la stessa coscienza sono per l’induismo solamente delle “coperture” sottili che rivestono l’anima incarnata parimenti al corpo fisico. Nel confronto dialettico tra le scuole di pensiero, era lecito e implicito accettare l’idea che ogni sforzo di spiegare e dimostrare la realtà suprema era impossibile in termini oggettivi. Al contrario era riconosciuta la prerogativa dell’anima individuale di potersi accostare alla realtà super soggettiva dell’Anima Suprema, soggettivamente.
Se pensiamo in maniera puramente soggettiva, nel nostro immaginario, come percepiamo l’entità suprema? Se proviamo per un attimo a riflettere su che idea personale abbiamo della natura, dell’aspetto, della forma, delle qualità e infine degli attributi che possiede Dio, ci troviamo a dover considerare quanto poco sappiamo su questo argomento. L’induismo ci fornisce con incredibile accuratezza e profondità di descrizioni, racconti, riflessioni filosofiche, moltissime informazioni su questo tema, con particolare attenzione per gli aspetti che descrivono la forma di Dio.
Nell’induismo, nascosti dietro la moltitudine di divinità e personaggi mitologici, si possono individuare due fondamentali indirizzi di pensiero:
- il primo si delinea secondo l’idea che Dio sia una Persona Suprema, con attributi, qualità e una personalità trascendentali: in sanscrito il termine Bhagavan identifica l’aspetto personale di Dio;
- il secondo si accosta a Dio nella sua forma impersonale, priva di attributi, qualità e forme individuali. In sanscrito si chiama Brahman;
Queste due tradizioni determinano i contenuti di tutte le più importanti scuole e successioni discepolari, influendo sui tratti salienti del pensiero filosofico e religioso dell’induismo e dello Yoga.
L’idea che Dio sia una Persona Suprema, costituisce il tratto determinante della scuola Personalista. In questa tradizione, Bhagavan, Dio, è l’essere supremo che esiste eternamente nella sua dimora trascendentale al di là dei mondi materiali. Possiede innumerevoli forme personali, che esistono tutte simultaneamente ma che originano tutte da una forma primordiale, Bhagavan Krishna. Questo dato è utile per comprendere che, tra le moltissime divinità presenti in India, è necessario distinguere le forme e manifestazioni totali o parziali di Dio, e altri esseri, chiamati Deva, che possiedono caratteristiche speciali e vengono adorate come divinità, ma vengono create e distrutte come le altre anime individuali. A tal fine, è necessario iniziare con lo spiegare che le manifestazioni divine si suddividono in due categorie:
- Prakasha che sono le manifestazioni dirette di Krishna e vengono chiamate anche Prabhava.
- Vilasa che sono espansioni di Krishna, cioè forme parziali (Amshavesha) e dotate di poteri divini (Shaktyavesha).


Leggi la seconda parte dell’articolo

In India l’infinito e l’assoluto, se esistono, possono essere inspiegabilmente e simultaneamente, irrazionalmente e illogicamente, uguali e diversi, infiniti e simultaneamente infinitesimali, eterni e temporali, una persona assoluta originale e infinite emanazioni o espansioni che coesistono simultaneamente alla coscienza totale impersonale...

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...
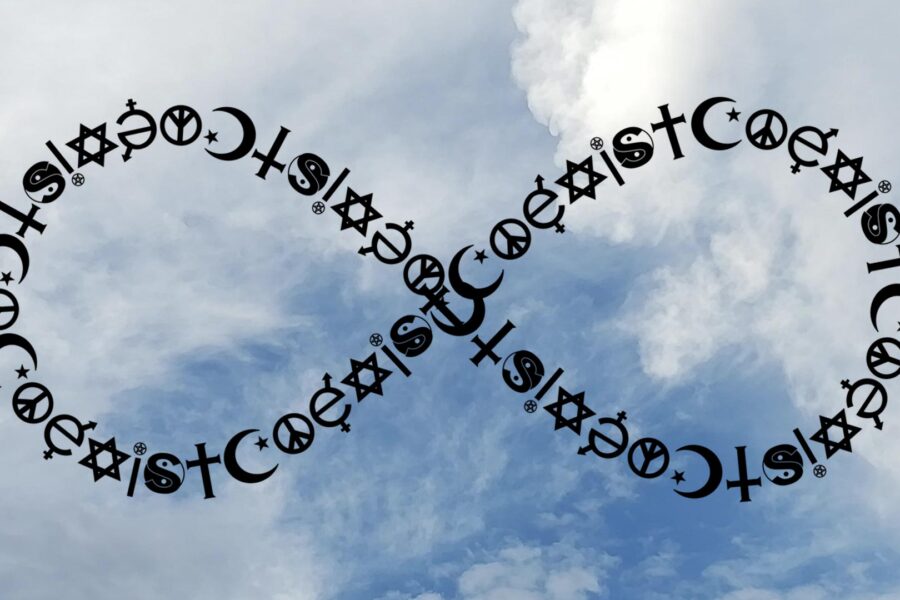
In molti casi, la religione è più il simbolo visibile di un conflitto che la sua vera causa. ma è arrivato il momento di affrontare i conflitti religiosi e promuovere la pace attraverso il dialogo interreligioso. Come hanno discusso alla Conferenza Mondiale per il Dialogo e la Cooperazione Religiosa...
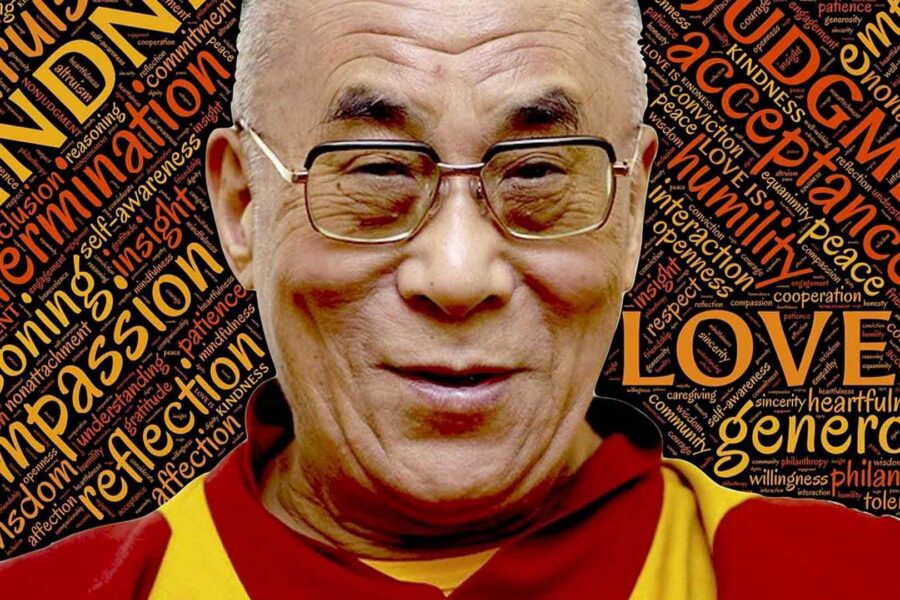
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...





