Nel tentativo di dare un punto di vista che sintetizzi e metta in connessione lo Yoga con la sua cultura di origine, cioè la filosofia e la spiritualità vedica indiana, in questi articoli cercheremo di comprendere come il concetto di sofferenza sia centrale nello sviluppo del pensiero indiano.
Vyadhi-roga è un termine sanscrito che designa il malessere, fisico e mentale. Il dolore fisico e il dispiacere mentale sono la manifestazione predominante di quasi tutti i disturbi così come delle malattie. Secondo la cultura vedica, tutte le malattie sono Karmaja, sono generate cioè nel karma individuale. Karma a sua volta designa l’insieme delle reazioni positive e negative alle azioni compiute nelle vite passate, che generano i loro frutti nella vita corrente. Così nella filosofia indiana Karma e Vyadhi hanno una relazione di causa ed effetto.
Negli Yoga Sutra di Patanjali, uno dei testi di riferimento della cultura dello Yoga, si parla di un concetto fondamentale per la comprensione delle motivazioni che muovono a dedicare il proprio impegno nella pratica dello Yoga stesso: il tema dell’origine della sofferenza materiale e delle sue cause. Il termine che si utilizza negli Yoga Sutra è Klesha o Kleshagni, il fuoco della sofferenza, il cui significato letterale è afflizione o sofferenza materiale. In questa accezione sono incluse le cause di tale sofferenza, così elencate: Avidya, Asmita, Raga, Dvesha e Abhinivesha.
Avidya è l’ignoranza, cioè la tendenza a confondere l’impermanente e il temporaneo con il permanente e l’eterno, confondere il sé materiale con l’anima. Asmita, il falso ego, è l’identificazione con il corpo. Raga rappresenta il forte desiderio e appagamento per la felicità materiale e per i mezzi che la forniscono. Dvesha indica l’odio o il rifiuto per l’infelicità e le sue cause. Infine, Abhinivesha, consiste nell’attaccamento istintivo e continuo per gli oggetti del nostro affetto e la paura di perderli. Si dice che questi cinque ostacoli separano il sé dalla pace interiore e lo costringono a soffrire in questo mondo attraverso i passaggi della nascita, Janma, della vecchiaia, Jara, della malattia, Vyadhi, e della morte, Mrtyu.
Dobbiamo inquadrare questa serie di concetti all’interno di quella che era l’antica società vedica indiana, nella quale lo Yoga si inseriva, definita dai principi del Varna-ashrama-dharma. Con il termine Varna si identificano le quattro classi sociali dell’epoca vedica, i Brahmana o intellettuali e sacerdoti, gli Kshatrya, i guerrieri e amministratori, i Vaishya, commercianti e mercanti e infine i Sudra, operai e servitori. La parola Varna viene variamente descritta come apparenza, colore e associata alla parola Jati che identifica la forma di esistenza degli esseri viventi.
A partire dalle descrizioni dei Veda fino ai racconti del Mahabharata, si narra che i Brahmana furono creati dalla bocca del Purusha, Vishnu, il Signore supremo, o da quella del primo essere creato, Brahma. La caratteristica determinante dei Brahmana è quella di ricevere e impartire il sapere attraverso il linguaggio, in particolare quello contenuto negli Shastra, gli antichi testi rivelati, che sono la rappresentazione sonora della divinità.
Gli Kshatrya sorgono dalle potenti braccia del Purusha e ne rappresentano la capacità di combattere il male, amministrare il bene e difendere i principi religiosi. I Vaisya, vengono generati dalle cosce della forma universale del Purusha e ne indicano la funzione di lavoratori che viaggiano per commercio, gestiscono l’economia e producono beni. Infine i Sudra sono considerati i servitori o collaboratori delle altre caste e vengono manifestati dai piedi del Purusha.
La nascita quindi in uno di questi ceti assume un significato che si pone oltre gli orizzonti di scala sociale occidentale e rientra in quel quadro di organizzazione della struttura universale del mondo materiale che discende dalla creazione divina. Così il Karma si pone come elemento di predestinazione che determina il tipo di nascita o incarnazione umana.

Il secondo vocabolo che forma la parola Varna-ashrama-dharma, indica le quattro tappe della vita, gli Ashrama, che sono così organizzati:
- la fase di studio e continenza, Brahmachariya, che parte dal sesto anno di vita e si completa verso la maggiore età, in cui si accettano diversi voti ricevendo le prime iniziazioni spirituali da un Maestro che, insieme all’insegnamento della grammatica e della logica sanscrita, impartisce la conoscenza delle scritture;
- la seconda fase nel processo di evoluzione religioso-sociale è quella dello sviluppo economico-produttivo ma anche la creazione di un contesto famigliare con il matrimonio, chiamata Grhasta;
- viene poi, dopo aver condotto una buona parte della propria vita all’interno della società, la fase del ritiro dalla vita sociale mantenendo ancora saldo il legame matrimoniale e condividendo con la compagna uno stile di vita ritirato e privo di ruoli sociali, chiamato Vanaprastha, nel quale ci si inizia a preparare ad affrontare il tema della separazione dell’anima dal corpo con la morte e l’adempimento dei propri doveri interiori;
- infine il voto di rinuncia, Sannyasa, delinea il percorso di abbandono definitivo di ogni legame sociale, culturale, famigliare e la rinuncia a qualsiasi possedimento materiale, per dedicarsi esclusivamente alla ricerca del sé interiore. Nel contesto degli Ashrama si pone in atto lo sforzo, il tentativo dell’essere vivente di accedere ad un livello di consapevolezza che conduca al raggiungimento del perfezionamento del proprio Karma, per anelare alla realizzazione del sé che conduce alla liberazione.

Infine la parola Dharma, che chiude il termine composito, designa il concetto di dovere ma, in una accezione più ampia, indica la via per condurre l’essere vivente verso la realizzazione interiore, mediante l’osservazione dei doveri prescritti. Si possono annoverare per esempio e in continuità a quanto appena detto, i Varna-dharma cioè i doveri prescritti per ogni classe sociale come ad esempio lo Kshatrya-dharma, i doveri propri della classe guerriera e amministrativa. Tutti questi doveri sono divisi nei tre settori o che contraddistinguono la società indiana, descritta nei Veda, chiamata Veda-kandha:
1. Karma-kanda, gli atti compiuti secondo le prescrizioni vediche per conseguire la liberazione dal karma, che a partire dall’idea filosofica che, per superare gli effetti del karma bisogna liberarsi dall’attaccamento verso i risultati delle proprie azioni, regolano con norme e codici di comportamento le attitudini mentali e le tipologie di azioni che sono ammesse o sconsigliate per il raggiungimento del fine ultimo.
2. Jnana-kanda, lo studio filosofico delle scritture secondo le prescrizioni vediche, per conseguire lo stato di sattva, virtù-conoscenza-illuminazione. Questo importante stadio è collegato alla concezione che la coscienza materiale si manifesta sotto quattro forme di identificazione:
- il Falso Ego cioè l’identificazione con il corpo-mente-famiglia-società;
- l’intelletto come sistema organizzato di discernimento, raziocinio e indagine di noi stessi e del mondo;
- la mente in sé come principale veicolo della coscienza che pensa e sente ma anche elabora le funzioni sensoriali;
- infine il sub-conscio dove dimorano le memorie latenti e le attitudini acquisite vita dopo vita.
Il terzo settore della divisione vedica, Upasana-kanda, è la ritualizzazione sacra e il compimento di sacrifici, secondo le prescrizioni vediche. Per ogni Varna-ceto sociale e in ogni Ashrama-tappa della vita religiosa, si trovano specifiche ritualità per ogni aspetto fondamentale nella vita di un uomo: dalla cerimonia per la nascita a quella per la morte, dal matrimonio alla rinuncia alla vita sociale, sono regolate secondo le indicazioni vediche, per stabilire una connessione sacra e inscindibile tra il mondo univoco e interessato dell’esistenza materiale con quello divino e multiplo della vita spirituale.

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...
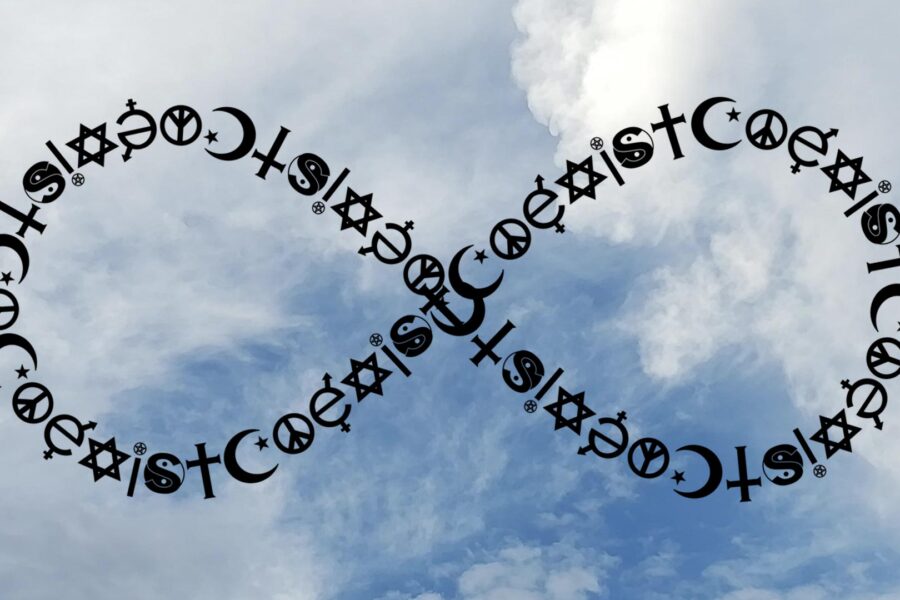
In molti casi, la religione è più il simbolo visibile di un conflitto che la sua vera causa. ma è arrivato il momento di affrontare i conflitti religiosi e promuovere la pace attraverso il dialogo interreligioso. Come hanno discusso alla Conferenza Mondiale per il Dialogo e la Cooperazione Religiosa...
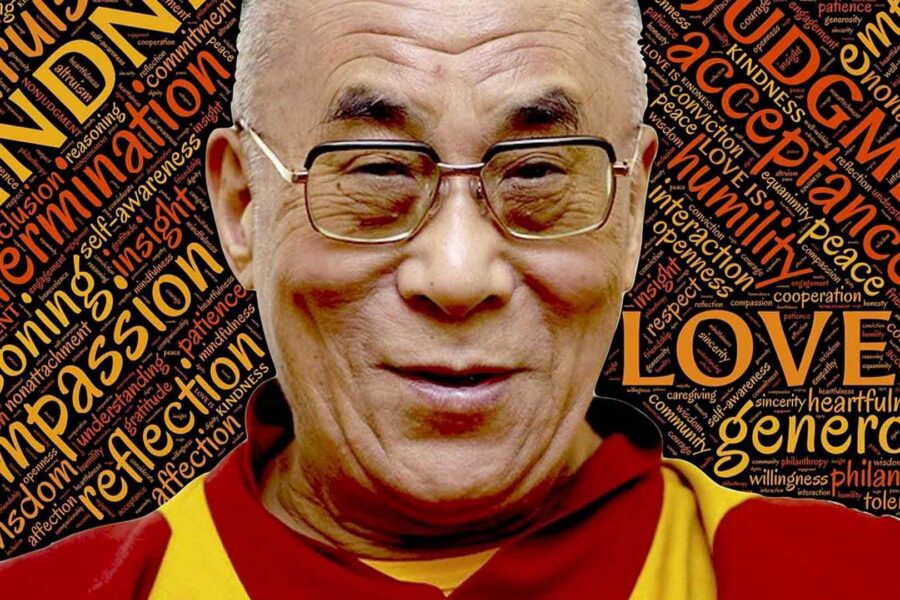
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...





