Maturità: dal latino maturĭtas -atis, derivato di maturus “maturo”
Quest’anno, 526 mila ragazzi si preparano alla Maturità, studiando intensamente per arginare l’ansia che potrebbe limitare ciò che hanno appreso. “Maturità” è il termine scelto da Giovanni Gentile nel 1923 per indicare l’esame conclusivo degli studi liceali, successivamente rinominato “Esame di Stato” da Luigi Berlinguer nel 1997.
Nonostante il cambio di nome, che intendeva sottolineare l’obiettivo di certificare conoscenze, competenze e abilità per il lavoro o per ulteriori studi, nell’immaginario collettivo rimane la Maturità, un evento indimenticabile. Certamente si tratta di un momento formativo significativo, un rito di passaggio nella nostra società, che segna una svolta e che, coincidendo spesso con il raggiungimento della maggiore età, rappresenta un traguardo, una soglia, l’inizio di una nuova fase.
È una presa di responsabilità, non un esame strettamente selettivo, dato che la maggior parte lo supera. È di breve durata, ma resta nella memoria. Rappresenta la fine di un percorso spesso faticoso, caratterizzato da evoluzioni personali a volte non lineari e piene di ostacoli. Le prove scritte offrono ai maturandi l’opportunità di un colloquio interiore, un’immersione nel proprio bagaglio di conoscenze. Gli orali, invece, sono l’occasione di presentarsi agli altri, tra cui qualche commissario che non si conosce, cercando di dare il meglio di sé.
Una questione di tempo
La maturità, come suggerisce il termine, ha sempre indicato una crescita, una trasformazione dall’infanzia all’età adulta. Tuttavia, l’adolescenza non termina più con la maggiore età, ma si prolunga, talvolta senza fine. Questa transizione è andata sfumando nel tempo, a causa dei cambiamenti nell’educazione e delle difficoltà a trovare un’occupazione, che ritarda l’indipendenza dalla famiglia. Finire le superiori fino a qualche decennio fa significava soprattutto poter votare, prendere la patente, guidare l’auto e scegliere il proprio destino, università o lavoro.
Se il futuro, simile a quello dei genitori, non piaceva, si aveva la speranza di cambiarlo in meglio. In passato, l’esame si svolgeva in un contesto sociale più omogeneo e ristretto ed era davvero un salto verso l’autonomia. Oggi, a cosa serve? I giovani sanno che dovranno impegnarsi molto dopo, che sarà necessario un quid in più.
Viviamo in una fase di grandi cambiamenti: climatici, geopolitici e soprattutto assistiamo alla rivoluzione digitale, che ci ha reso familiari strumenti come i cellulari, ora molto più che semplici telefoni, e ci ha messo dinnanzi l’intelligenza artificiale. Ora diventare grandi significa fare un passo nel vuoto.
Insicuri nelle scelte
Alla fine delle lezioni quest’anno ho somministrato un questionario ai miei studenti di quarta. La maggior parte di loro dichiara di studiare perché ha voglia di imparare, quindi mostra un desiderio innato di apprendere e trae soddisfazione dai risultati del proprio impegno, indipendentemente dalle pressioni della famiglia e della scuola.
Alla domanda sul futuro, universitario o lavorativo, però, c’è una generale indecisione. Alcuni ragazzi hanno un orientamento più definito, altri cercano percorsi alternativi che combinino passione e creatività. Alcuni sono interessati più alla disciplina che andranno ad approfondire che alla professione da svolgere, mostrando quindi una buona dose di curiosità intellettuale. Non sono tanto interessati al “come”, ma al “cosa” faranno.
I mestieri cambiano, e la paura che l’intelligenza artificiale possa sostituire alcune mansioni umane, rende tutto fluido e sfuggente agli occhi degli adolescenti. Una cosa che i miei studenti non vogliono è lavorare nel campo dell’intelligenza artificiale, che trovano fredda e non meritevole dell’impegno di una vita.
I problemi e le sfide attuali
Di fronte ai cambiamenti, agli sconvolgimenti e alle incertezze economiche, i giovani si sentono insicuri, cambiano idea frequentemente. Anche noi adulti, le guide, spesso non sappiamo quale futuro indicare, poiché anche noi facciamo fatica a comprendere le conseguenze delle attuali trasformazioni. Le scelte sono difficili e niente sembra concreto.
I giovani perdono la motivazione e la fiducia in quelli che dovrebbero essere i loro motivatori. Gli esempi intorno a loro di infelicità e insoddisfazione abbondano, e temono di fare la stessa fine, per cui provano ad allontanarla con tutte le loro forze, anche ritardando le decisioni. Auguro loro di creare un mondo che sia adatto a loro. Così la Maturità potrà essere ciò che in senso letterale significa: “essere maturo”, aver raggiunto una consapevolezza che include la capacità e la volontà di continuare a svilupparsi in tutti gli aspetti dell’esistenza.


Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...
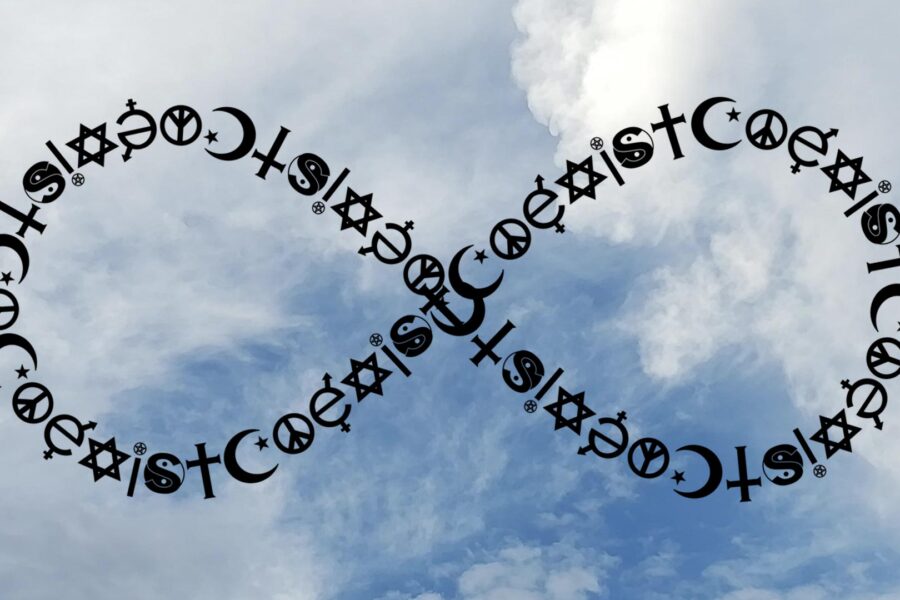
In molti casi, la religione è più il simbolo visibile di un conflitto che la sua vera causa. ma è arrivato il momento di affrontare i conflitti religiosi e promuovere la pace attraverso il dialogo interreligioso. Come hanno discusso alla Conferenza Mondiale per il Dialogo e la Cooperazione Religiosa...
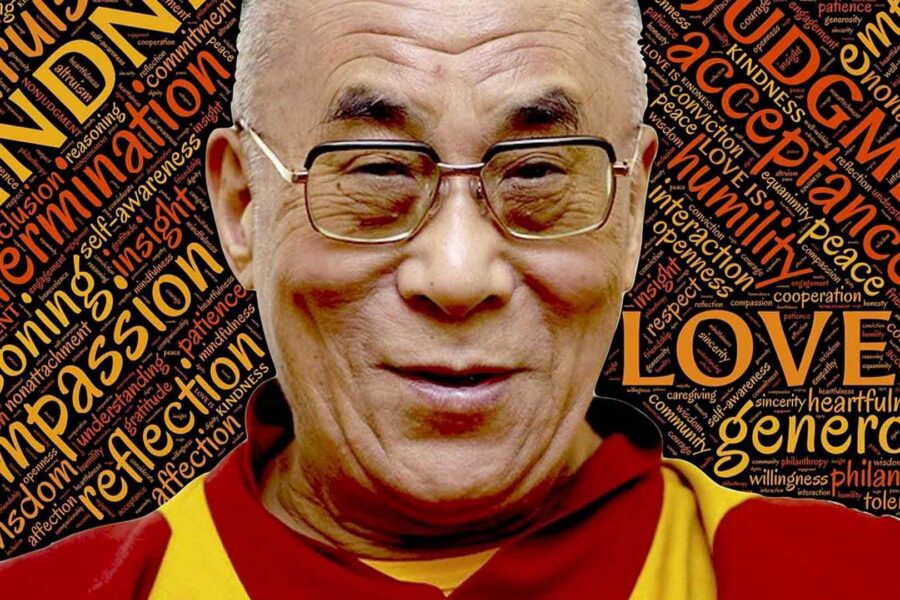
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...

Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...





