È disponibile su Netflix la mini serie, in sei puntate, La vita bugiarda degli adulti, tratta da un romanzo di Elena Ferrante. Giovanna, una quindicenne napoletana, oltre ai tormenti tipici della sua adolescenza si trova immersa in una dinamica familiare altamente disfunzionale. Suo padre (interpretato da Alessandro Preziosi), un affascinante intellettuale di larghe vedute, durante una discussione con la moglie sui brutti voti della ragazza, si lascia scappare una battutaccia: Giovanna assomiglia sempre di più alla terribile zia Vittoria. La ragazza origlia questa maldicenza ma, non conoscendo direttamente la zia, non si rende conto dell’effettiva portata del paragone. Sa solo che è negativo. Ovviamente scatta l’attrazione fatale. Giovanna cerca la zia Vittoria, interpretata da una straordinaria Valeria Golino. Per le prime due puntate veniamo tutti sedotti dalla personalità dirompente, schietta ed essenziale della zia, che “uccide il padre” di Giovanna, oltrepassando con godimento la freudiana spietatezza. Ma quando sembrava che Giovanna avesse finalmente trovato una figura adulta di riferimento ecco che attorno a lei anche i nuovi castelli si sgretolano, generando ulteriore caos.
Dopo i primi due episodi, veramente belli, la serie diventa un po’ lunga e stiracchiata. Ma lo spunto di riflessione rimane alto: quante bugie diciamo continuamente? Quanto mentiamo sugli altri a nostro vantaggio? Quanto mentiamo a noi stessi? Che film ci raccontiamo? Con questa legna potremmo ardere un fuoco millenario, nutrito da innumerevoli spunti letterari e cinematografici.
Fra le tante, mi vengono in mente le considerazioni potenti di P.D. Ouspensky, nel suo libro La quarta via, nel quale egli si domanda perché non riusciamo a essere veramente consapevoli. La risposta risiede nella menzogna, definita come il più grande ostacolo per lo sviluppo della consapevolezza umana. Mentire è un problema serio perché «la psicologia del mentire è veramente la parte più importante dello studio dell’essere umano. Se un uomo potesse essere descritto come un tipo zoologico, sarebbe definito “l’animale bugiardo”».
La bugia dunque è la più grande zavorra del nostro percorso di evoluzione personale e di specie. Ma cosa vuol dire mentire? Ouspensky è tranciante: «Pensiamo e agiamo sempre come se conoscessimo la verità». Questo è mentire. E anche se riuscissimo costantemente a “sapere di non sapere” dovremmo fare i conti con «parecchi tipi differenti di mentire e alcune forme assai sottili, difficili da scoprire in noi. Negli altri le vediamo con relativa facilità, non in noi stessi». Insomma la strada verso la verità è lastricata di trabocchetti, ai quali è difficilissimo sfuggire.
Incalza Ouspensky: «Abbiamo opinioni su tutto e tutte queste opinioni sono bugie, specialmente riguardo a noi stessi. Noi, circondati da queste bugie, nati ed educati in queste bugie, non possiamo essere diversi da come siamo; siamo proprio il risultato, il prodotto, di questa menzogna».
Oltre a riguardare noi tutti queste considerazioni calzano a pennello sui personaggi della nostra serie: tutti si raccontano, e raccontano, una storia, una verità. Giovanna fa davvero una fatica enorme a capirci qualcosa in questo mondo di adulti che sono più confusi e zavorrati di lei. Finché cerca la verità assoluta Giovanna resta sotto scopa, vivendo le vite degli altri. Quando finalmente si contamina facendo esperienza della sua verità, riesce a vedere se stessa, buca la bolla e prende il volo.
Ma come si fa a rapportarsi con la verità rimanendo invischiati in questo mondo nel quale dobbiamo creare delle corazze per difenderci? Swami Satyananda, nel suo commentario a Yogasutra, ci dà una traccia molto utile: «Solo la persona che sa soppesare ogni sua parola può dire la verità». Quindi non dobbiamo né mentire (che è un errore dal punto di vista karmico), né essere troppo trasparenti (che è un errore dal punto di vista relazionale), ma piuttosto lavorare per sviluppare una coscienza che sappia metterci in bocca quanto necessario allo scopo, mantenendo pura la nostra intenzione.
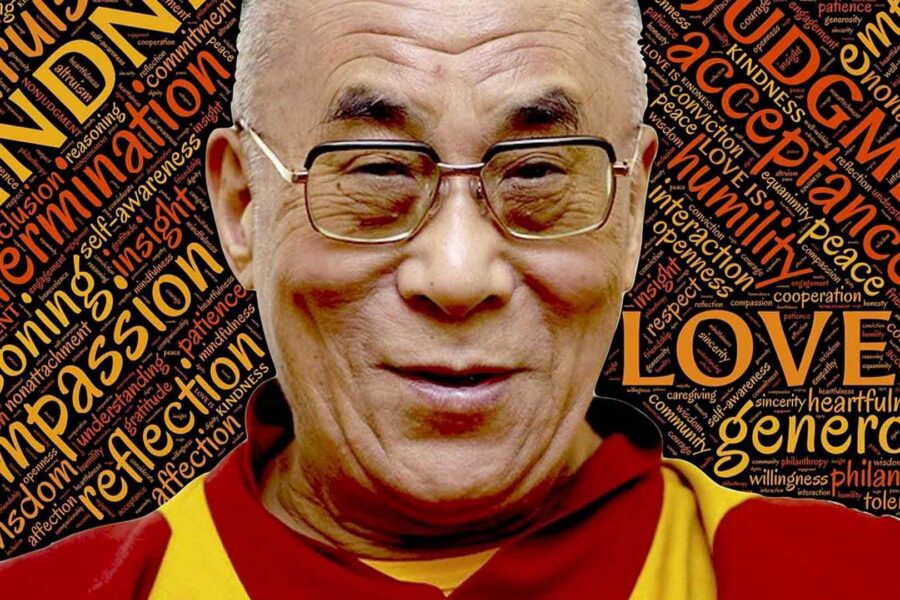
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...
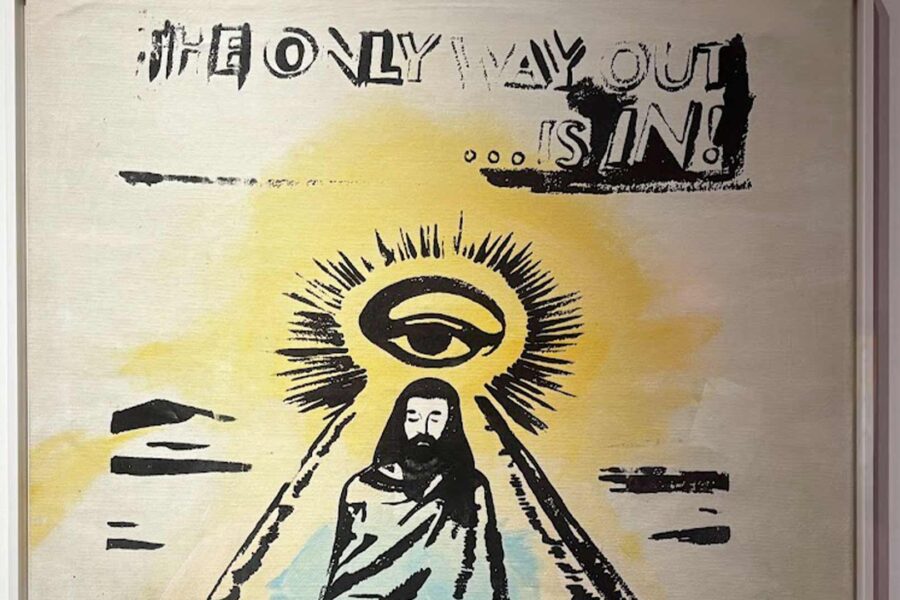
Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...

Le Quattro Nobili Verità, cuore dell’insegnamento del Buddha, non parlano solo a monaci e meditanti. In questo articolo le “leggeremo” guidati da parole antiche e brani indimenticabili. Perché anche un verso o una melodia, a volte, possono far girare la ruota del risveglio

Il maestro Ramin Bahrami, 48 anni, qualche giorno fa al Teatro Antico di Taormina ha ricevuto un prestigioso premio al Taormina Book Festival, ma il suo cuore era con la mamma, 89 anni, che «era partita da poco per andare a trovare l’anziana sorella» E ha lanciato un messaggio di pace. Perché, dice «dobbiamo capire, che siamo parte di una partitura più grande di noi che deve produrre un fiore di bellezza»

L’idea che possano esistere altri mondi oltre il nostro ha da sempre acceso la fantasia di scrittori e lettori, diventando col tempo anche oggetto di speculazione scientifica. Tra letteratura e fisica teorica, il concetto di universi paralleli ha attraversato i secoli come un ponte tra immaginazione e conoscenza, trovando nuova linfa negli esperimenti più recenti, come quello condotto dall’antenna ANITA nei cieli dell’Antartide...





