«Se anche tu pensassi che l’anima muore e rinasce infinite volte, non avresti alcun motivo di lamento, o Arjuna dalle possenti braccia. (2.26)
La morte è certa per chi nasce, e certa è la nascita per chi muore. Poiché ciò è inevitabile, non dovresti angustiarti così. (2.27)
Chi dimora nel corpo non può mai essere ucciso. Non dovresti quindi piangere per nessuno, o discendente di Bharata. (2.30)
Consapevole del tuo dovere [dharma] di kshatriya [guerriero], dovresti sapere che non c’è impegno migliore per te del combattimento fondato sui principi religiosi [dharma]. Non hai dunque motivo di esitare. (2.31)
O figlio di Kunti, se muori sul campo di battaglia raggiungerai i pianeti celesti e se vinci regnerai sulla Terra. Alzati dunque, e combatti con determinazione». (2.37)
Prima di concentrarci sulla parola chiave di questa sezione della Bhagavad Gita, la parola «dharma», cerchiamo di cogliere il grande insegnamento pratico che se ne può trarre.
Come Krishna dirà nel verso successivo, in questo specifico frangente sta esponendo ad Arjuna tutte le motivazioni logiche, razionali, per cui non dovrebbe avere dubbi sul combattere con determinazione questa guerra. In primis c’è il fatto che l’anima non muore mai, e se anche morisse, non farebbe nessuna differenza: la filosofia materialista o, come la chiamano oggi, naturalista, prevede infatti che la coscienza nasca spontaneamente dalla materia, come suo sottoprodotto.
Quindi, se qualcuno è malvagio e fa soffrire gli altri, se anche dovesse morire, non c’è una vera perdita dal punto di vista prettamente filosofico, di ragionamento nudo e crudo. Se uno è materialista, la sua legge è quella del famoso motto romano: «Mors tua, vita mea». Qui Krishna, ma mi sembra ovvio, non sta incitando Arjuna a pensarla proprio così, ma, nell’ambito del discorso che sta facendo, aggiunge questo argomento proprio per illustrare l’assurdità di quel pensiero, che porta il caos nella società. Infatti questo è esattamente il risultato che abbiamo ottenuto oggi: un mondo sull’orlo del baratro, risultato della visione naturalista e materialista che oggi impera, specie tra gli intellettuali: sì, tanto avanzamento tecnologico, ma per il resto…
Il vero centro del discorso in questi versi del secondo capitolo è proprio il concetto di dharma. Il termine dharma deriva dalla radice sanscrita «dhr» che significa «sostenere». Tutto ciò che mantiene e sostiene l’Universo, il mondo, tutti gli esseri viventi e la società è dharma. Spesso il termine dharma viene tradotto con «principi religiosi», o norme della religione, perché nei Veda il termine religione ha lo stesso significato che ha in latino, cioè quello di riconnettersi al proprio sé, alla legge cosmica, alla Natura, alla giustizia, e in ultima analisi al divino. Krishna non sta promuovendo una religione nel senso comune del termine: dharma non è una religione, ma «LA» religione nel senso più alto, cioè tutto ciò che ci ri-connette al Cosmo, al divino. Ri-connette perché ci siamo disconnessi, essendo imbrigliati nelle leggi del karma e del samsara, il ciclo perenne di nascite e morti, e abbiamo, appunto, bisogno di ri-connetterci.
Dharma significa anche il dovere, quello che ci spetta fare perché abbiamo un certo ruolo nel mondo, nella società. Arjuna è un guerriero, il suo dharma (dovere) è combattere per la giustizia, per la libertà, per proteggere chi viene abusato e sfruttato. Sarebbe troppo facile ritirarsi dal campo di battaglia proprio nel momento in cui servono «le possenti braccia» di Arjuna. Arjuna si è potuto allenare e preparare come guerriero perché è stato sostenuto da tutte le altre classi sociali, con il loro lavoro e le tasse, per tanti anni. Adesso è il suo momento per ricambiare, e l’idea di ritirarsi dalla battaglia per lui è a-dharma, l’opposto del dharma (la «a-» davanti a dharma è infatti l’alfa privativa, che produce il contrario della parola che precede). Ecco il vero senso di questa parola magnifica, dharma, il cui sostegno dovrebbe essere faro e bussola di ognuno di noi, tanto che negli antichi testi sapienziali vedici vige il teorema fondamentale della vita: «Chi sostiene il dharma, è dal dharma sostenuto». E non è un semplice gioco di parole: certamente può essere difficile compiere scelte impegnative nella vita, invece di seguire allegramente gli istinti e i desideri del momento, ma chi riesce a sacrificare il proprio interesse egoico del momento in nome di un bene più grande e del compiere la propria missione della vita, può sentire la potenza interiore del sostegno del dharma.
A questo punto la domanda sorge spontanea: «Ma quale sarà mai il mio dharma? Arjuna era un guerriero, ma io?». Ritorna il solito problema del trovare il senso della propria vita, senso che andiamo a cercare nel lavoro più adatto o redditizio per noi, oppure nel lavoro che ci rende davvero appagati, specie dopo la crisi di mezza età. Ma qui invece Krishna si focalizza su altro, non è la ricerca eterna del proprio dharma che fa la differenza, ma è seguirlo con determinazione da subito, partendo dalla situazione in cui siamo oggi. Che uno sia padre, madre o figlio, imprenditore, lavoratore dipendente, sacerdote, impiegato o re poco importa, ogni ruolo sociale ha già il suo dharma, e siamo tenuti a seguirlo. Ecco perché la parola dharma può essere tradotta anche con «legge», perché, appunto, nella società, sono le leggi che regolano molti dei nostri doveri sociali.
Krishna dunque non si preoccupa di soffermarsi qui su qual è il dharma in sé di una persona, tanto che, in un certo senso, potremmo anche scegliere un ruolo sociale “a caso”, anche solo perché ci piace più delle altre possibilità che abbiamo di fronte. La cosa importante è poi seguire quello specifico dharma con determinazione, prenderci seriamente la responsabilità. Krishna sta parlando con Arjuna su un campo di battaglia, perciò lo incita a combattere per una giusta causa perché il suo dharma è quello, ovvero lui stesso ha preso quella strada e quella responsabilità. Ma poi conclude il ragionamento così:
«Combatti senza considerare gioia e dolore, guadagno o perdita, vittoria o sconfitta. Così facendo non incorrerai nel peccato». (2.38)
Svolgere il proprio dovere con distacco è la strada per liberarsi dalla catena infinita di azioni e reazioni karmiche, che ci tiene imprigionati nella rete della materia. Bisogna evitare di incorrere nel peccato, in sanscrito papa, che non è la mera rottura di una regola religiosa puritana, o un giudizio bigotto di chi vede nella religione una serie di regole scritte ma spesso non capite. Il peccato è infrangere il dharma, cioè papa e a-dharma sono sinonimi: il peccato è rompere equilibri naturali, andare contro la propria natura, contro il proprio impegno e responsabilità, in ultima analisi è andare contro il proprio sé, la scintilla divina che anima i corpi di tutti gli esseri viventi. Il peccato è agire sulla base dei nostri interessi egoistici del momento, non considerando il dharma in tutte le sue sfaccettature, il bene profondo nostro e di tutte le creature.
Ma adesso Krishna sta per fare un passo ulteriore, il viaggio sul vascello della Conoscenza è ancora lungo…
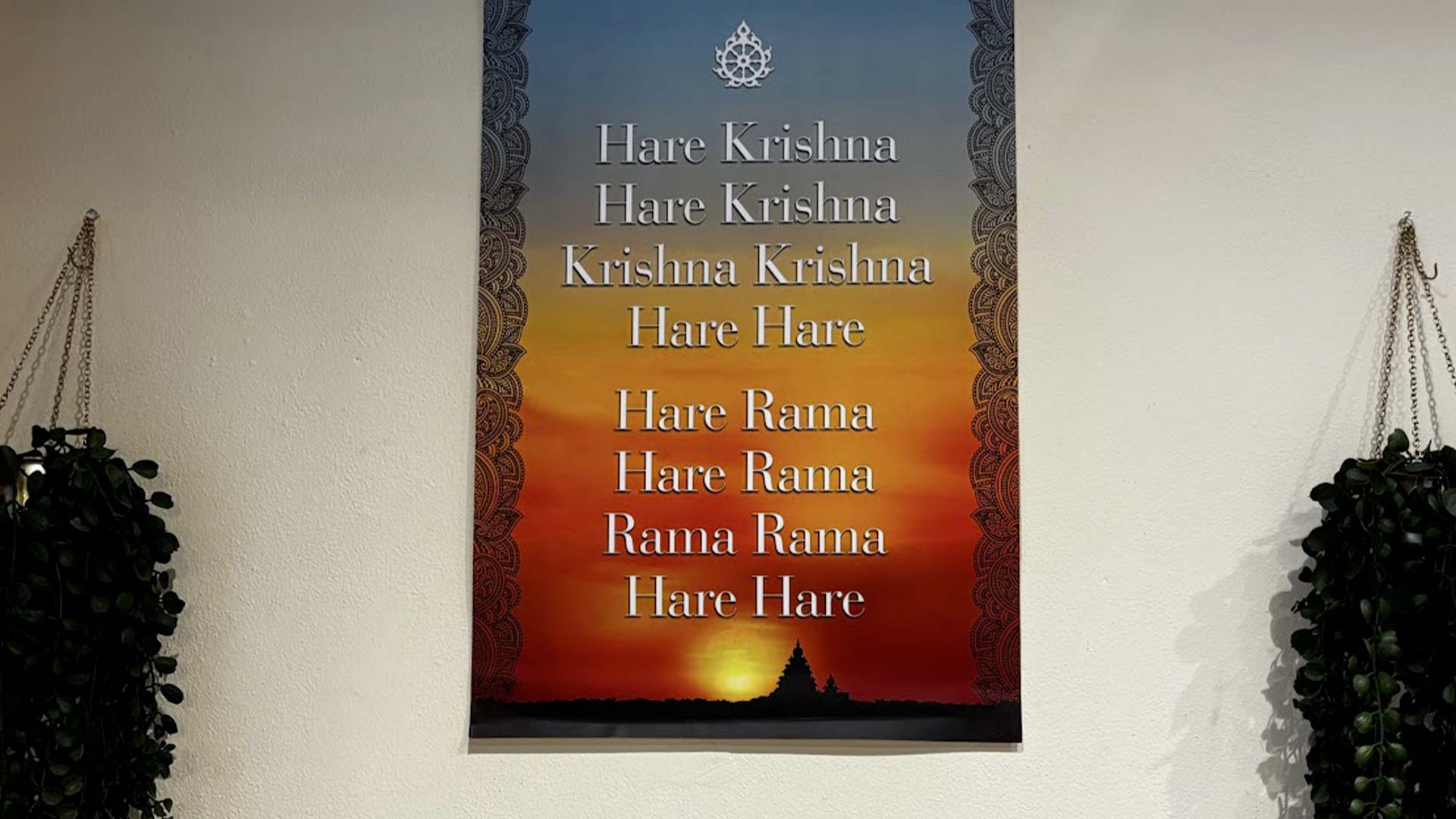
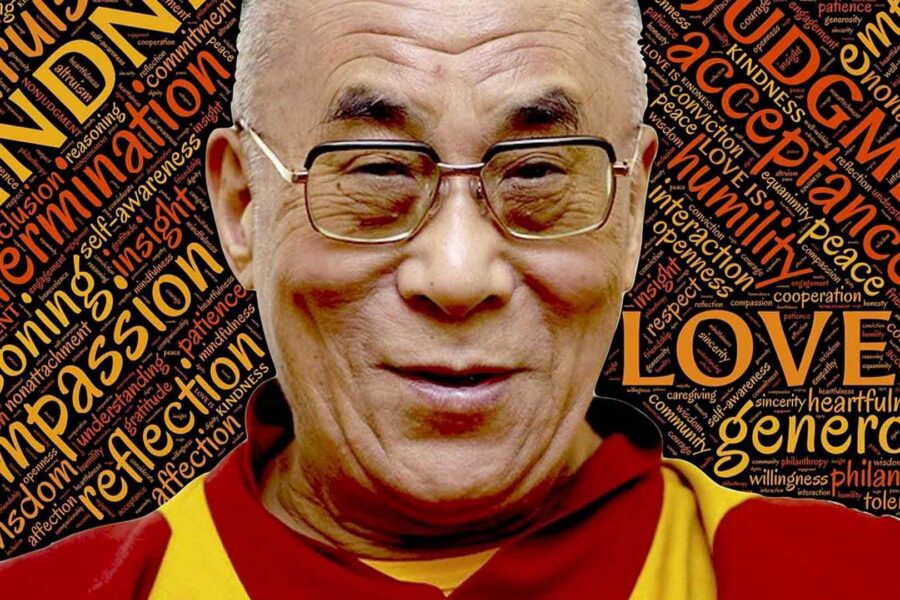
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...
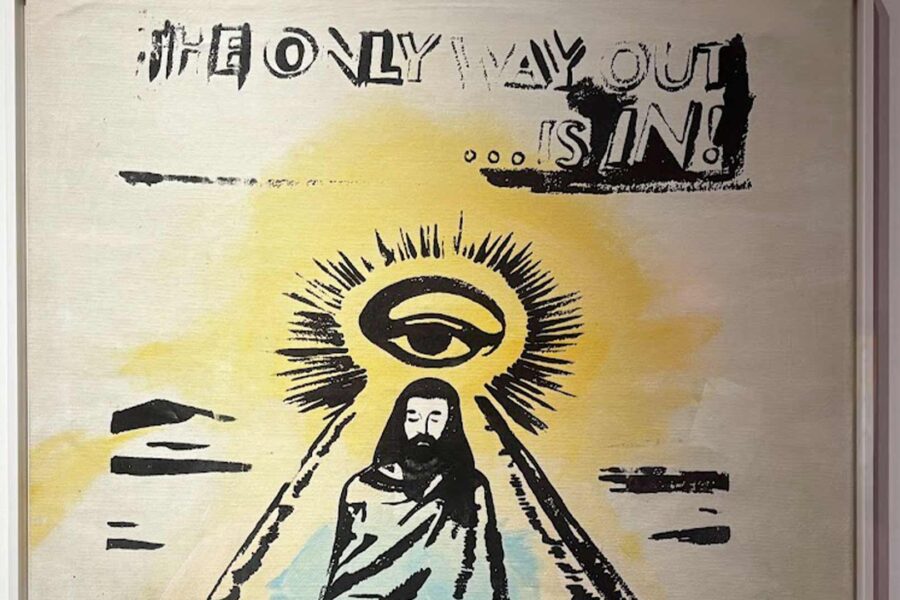
Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...

Le Quattro Nobili Verità, cuore dell’insegnamento del Buddha, non parlano solo a monaci e meditanti. In questo articolo le “leggeremo” guidati da parole antiche e brani indimenticabili. Perché anche un verso o una melodia, a volte, possono far girare la ruota del risveglio

Il maestro Ramin Bahrami, 48 anni, qualche giorno fa al Teatro Antico di Taormina ha ricevuto un prestigioso premio al Taormina Book Festival, ma il suo cuore era con la mamma, 89 anni, che «era partita da poco per andare a trovare l’anziana sorella» E ha lanciato un messaggio di pace. Perché, dice «dobbiamo capire, che siamo parte di una partitura più grande di noi che deve produrre un fiore di bellezza»

L’idea che possano esistere altri mondi oltre il nostro ha da sempre acceso la fantasia di scrittori e lettori, diventando col tempo anche oggetto di speculazione scientifica. Tra letteratura e fisica teorica, il concetto di universi paralleli ha attraversato i secoli come un ponte tra immaginazione e conoscenza, trovando nuova linfa negli esperimenti più recenti, come quello condotto dall’antenna ANITA nei cieli dell’Antartide...





