Cosa c’è tra la Terra e il Cielo. Cosa c’è tra la terra e il cielo in e di Pasolini.
Diceva Pasolini: «È impossibile per me definirmi. Sono lo specchio dell’infinito».
Credo che la maledizione/benedizione poetica di Pasolini stia in questa definizione di sé: «Sono lo specchio dell’infinito». La sua visione di sé come di uno specchio bidirezionale che riflette il cielo nella carne e la carne nel cielo. E che perciò non può godere appieno né dell’una né dell’altro.
Considerava la sua omosessualità una sorta di maledizione: «Io ero nato per essere sereno, equilibrato, naturale», disse, «la mia omosessualità era in più, era fuori, non c’entrava con me. Me la sono sempre vista accanto come un nemico, non me la sono mai sentita dentro». Aveva chiesto a Ungaretti se esistesse la normalità. E il grande poeta rispose: «Tutti gli uomini sono a loro modo anormali e in un certo senso in contrasto con la natura. Lo stesso atto di civiltà è un atto di prepotenza sulla natura, è un atto contro natura».
Ma lui aspirava al Cielo anche se era fatto di carne come voi e me. E allora si dibatteva nel suo corpo e nelle sue contraddizioni. Più di noi perché era un poeta e il poeta è più vicino al Cielo, anche se non lo sa.
E via con le sfide. A quasi 40 anni, lui che si è sempre definito scrittore, ha scelto un altro linguaggio per provare a esprimere l’impossibile, il linguaggio del cinema, «la lingua scritta della realtà», come lo definì lui.
Un linguaggio tra la poesia e l’immagine, tra la vastità del mondo e il suo microcosmo di innamorato del suo Friuli, tra lo spettatore e una macchina da presa. La macchina da presa porta sullo schermo il suo sguardo laico che però – sono parole sue – lo portava a vedere le cose come miracolose. Perché – ripeteva – aveva una visione religiosa del mondo.
Per lui reciteranno Orson Welles, Totò, Eduardo De Filippo, Anna Magnani, Elsa Morante, Adriana Asti, Maria Callas, Silvana Mangano…
Eppure. Eppure nella sua vita troppo breve collezionò decine di processi e più di 100 denunce. Il più grande intellettuale del Dopoguerra era considerato un pornografo. Ma lui diceva: «Il sesso e l’escatologia sono politica». Nell’ultima intervista, che è ripresa nel film di Abel Ferrara con uno straordinario William Dafoe, diceva che «scandalizzare è un diritto ed essere scandalizzato è un piacere. Chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista».

Ecco perché da Ragazzi di vita in poi non ha mai temuto di scandalizzare. E così il suo primo film, Accattone è anche il primo film della storia della cinematografia italiana a essere vietato ai minori di 18 anni. Accattone racconta la storia di un uomo del sottoproletariato romano, Vittorio Cataldi, protettore vigliacco di una prostituta che non a caso si chiama Maddalena; Vittorio si innamora di Stella e in questo amore cerca il riscatto, ma solo in punto di morte questa «figura Christi» dichiara di avere trovato la sua liberazione. La vita è una condanna nella carne, solo la morte porta verso il cielo: «È assolutamente necessario morire, perché, finché siamo vivi, manchiamo di senso e il linguaggio della nostra vita è intraducibile. L’unica cosa che dà una vera grandezza all’uomo è il fatto che muoia. Cioè, l’unica grandezza dell’uomo è la sua tragedia».
Pasolini si dichiara ateo, ma realizza Il Vangelo secondo Matteo, il primo film di una trilogia sacra che consideriamo questa sera, e dice che lo ha potuto fare proprio perché non cattolico, perché non aveva neppure le inibizioni di un cattolico inconscio. La Chiesa lo plaude, i marxisti lo guardano con sospetto, solo Jean-Paul Sartre lo difende. La sua non è un’agiografia di Gesù, lui segue il Vangelo di Matteo in modo filologico. In uno straordinario susseguirsi di contraddizioni, di alto e di basso: descrive Cristo ma dice che si è ispirato a Lenin e al culto della personalità; fa sapere che avrebbe voluto nei panni di Gesù Jack Kerouac o Allen Ginsberg o Evtusenko; sceglie di affidare alla madre Susanna la parte di Maria perché in fondo quel Cristo messo in croce è anche Pasolini e quelli come lui, perseguitati e uccisi nel nome del moralismo borghese.
Pasolini è ossessionato dalla religione, eppure la sua profonda religiosità oscura il cielo. In Ricotta, mezz’ora di un film RoGoPaG, con quattro episodi di Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti (e scusate se è poco), racconta di un regista (Orson Welles) che deve mettere in scena la Passione di Cristo. Vilipendio alla religione di Stato. Scandalo con la prima del film interrotta dall’irruzione della polizia. Condannato in primo grado, assolto in Appello e poi la condanna confermata in Cassazione ma col reato estinto per amnistia. La parabola della giustizia italiana.
Scrisse Moravia che sarebbe stato più giusto «incolpare il regista di aver vilipeso i valori della piccola e media borghesia». Già. «Lei sa cos’è un uomo medio?», chiede in una scena Orson Welles regista al giornalista: «È un mostro! Un pericoloso delinquente». Secondo Pasolini, e non lo mandava a dire, «l’Italia», ha dichiarato, «ha la borghesia più ignorante d’Europa».

E poi c’è il terzo film di questa ipotetica trilogia tra la carne e il cielo, che è Teorema, del 1968. Per collocarlo storicamente, siamo nel periodo in cui Pasolini scrisse Il Pci agli studenti, poesia in cui dichiarava che i veri proletari erano i poliziotti. Non c’era un ambito che non si fosse inimicato.
La trama: in una famiglia ricca e borghese arriva un giovane ospite che uno a uno seduce tutti, dal padre alla madre, dalla figlia al figlio, alla governante. Quell’ospite si scoprirà essere Dio, o meglio – spiegherà Pasolini – un essere che svolge la funzione divina di Angelo Sterminatore della borghesia e quando se ne andrà, la vita di tutti sarà sconvolta. Tutti impazziranno tranne la governante che appartiene alla civiltà contadina e quindi le è consentita l’esperienza del sacro. Il film viene sequestrato per oscenità. Viene accusato perfino per particolari e dettagli che non esistono. Ma il successo di Pasolini è inarrestabile.
Fino all’epilogo. Nel ’71 a Enzo Biagi Pasolini disse che aveva bandito la parola speranza dal suo vocabolario. Il successo, aggiunse profetico, è l’altra faccia della persecuzione. «Non rifiuto l’insulto per strada perché io non sono un moralista». È andato incontro alla morte dopo averla accarezzata, sfidata. «Il cattolicesimo è la promessa che al di là di queste macerie c’è un altro mondo, e questo, invece, nei miei film non c’è».
Non sapeva, Pasolini, di essere lui il Cielo. O di essere l’angelo mandato dal Cielo per condurre 100 anni avanti un’Italia nei cui salotti borghesi ha pure pensato che tutti quei guai in fondo se li era cercati. Morte compresa.
Ma lui era il Cielo.
Ha confessato una volta: «La verità è che nei miei film esprimo delle gioie e del dolore. Contemporaneamente». E spiegava che dalle prime poesie in friulano in poi aveva usato «un’espressione della poesia provenzale, ab joi, l’usignolo che canta ab joi, per gioia, ma joi in provenzale aveva un significato particolare, di raptus, di esaltazione, di ebbrezza poetica. Questa espressione, ab joi, è l’espressione chiave di tutta la mia produzione. Ho scritto ab joi, cioè al di fuori di tutte le mie determinazioni, le mie spiegazioni, le mie definizioni culturalistiche. Il segno che ha dominato tutta la mia produzione è questa specie di nostalgia della vita, questa specie di esclusione che però non toglie amore per la vita, ma che lo accresce». Sì, Pasolini era il Cielo.
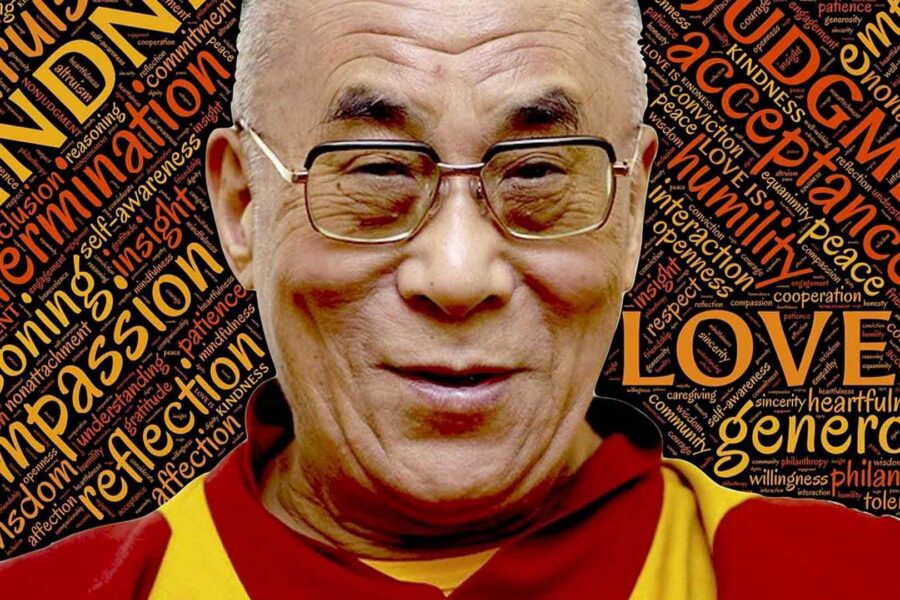
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...
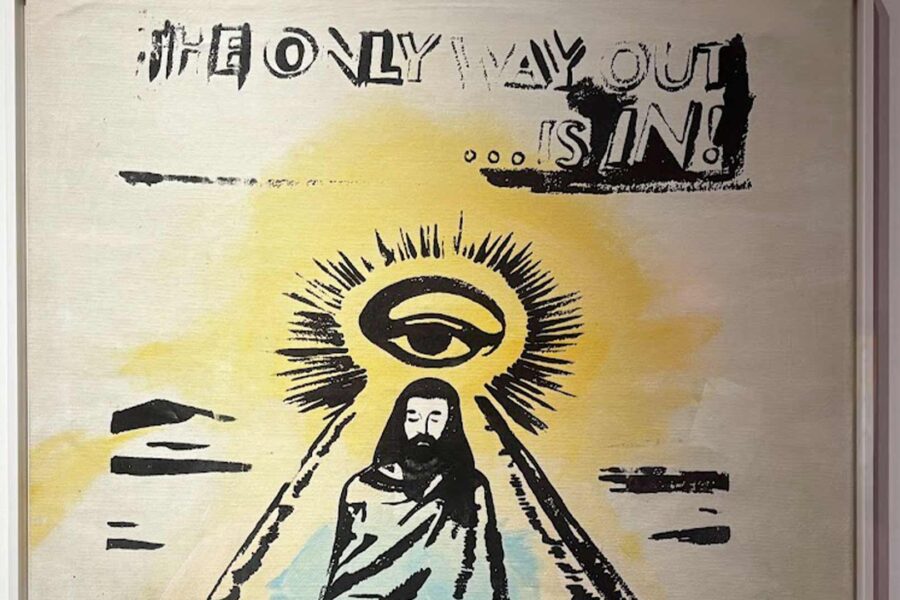
Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...

Le Quattro Nobili Verità, cuore dell’insegnamento del Buddha, non parlano solo a monaci e meditanti. In questo articolo le “leggeremo” guidati da parole antiche e brani indimenticabili. Perché anche un verso o una melodia, a volte, possono far girare la ruota del risveglio

Il maestro Ramin Bahrami, 48 anni, qualche giorno fa al Teatro Antico di Taormina ha ricevuto un prestigioso premio al Taormina Book Festival, ma il suo cuore era con la mamma, 89 anni, che «era partita da poco per andare a trovare l’anziana sorella» E ha lanciato un messaggio di pace. Perché, dice «dobbiamo capire, che siamo parte di una partitura più grande di noi che deve produrre un fiore di bellezza»

L’idea che possano esistere altri mondi oltre il nostro ha da sempre acceso la fantasia di scrittori e lettori, diventando col tempo anche oggetto di speculazione scientifica. Tra letteratura e fisica teorica, il concetto di universi paralleli ha attraversato i secoli come un ponte tra immaginazione e conoscenza, trovando nuova linfa negli esperimenti più recenti, come quello condotto dall’antenna ANITA nei cieli dell’Antartide...





