Seconda parte
Lo sforzo viene portato all’estremo da alcune scuole di yoga tantrico che includono, nel loro percorso, pratiche attinenti la sfera sessuale. Nella Śiva Samhitā troviamo la descrizione del vajronī-mudrā, una particolare contrazione che consente allo yogin di non disperdere il proprio seme, e contemporaneamente assorbire i fluidi femminili, durante l’atto sessuale rituale. Questo gesto riassumerebbe, sublimandola, la congiunzione fra bindu e rajas, maschile e femminile, sole e luna, ed è chiaramente associabile ad uno sforzo fisico e mentale non indifferente, raggiungibile solo da pochissimi individui, per lo più devoti del tantra della mano sinistra.
Uno dei veri e propri leitmotiv tantrici, e dunque hatha-yogici, è il concetto di abhyâsa, che esprime le caratteristiche che dovrebbe possedere la pratica: ripetizione, costanza, dedizione. Solo attraverso uno sforzo ripetuto costantemente nel tempo, e con tutto il cuore (nisthā), si ottengono risultati. Così dicono i saggi e i maestri. Ma come va gestito questo sforzo?
A prescindere dalle trasformazioni che ha attraversato nel corso dei secoli la pratica di āsana, tutti i manuali di hatha-yoga, anche quelli più recenti, raccomandano di eseguire le tecniche descritte dai vari anga in una precisa successione. Non si può passare all’āsana, alla mudrā, o al prānāyamā successivo se prima non si è raggiunta la padronanza di quello precedente. Solo in questo modo possiamo tenere una posizione “in assenza di sforzo”, come dice Patañjali, e accedere ai vertici del progetto: lo stato meditativo e il samādhi. A questo punto non rimane che domandarci: quante volte nella nostra pratica dimentichiamo di cercare stabilità e comodità? E quante volte, invece, dopo aver messo in atto lo sforzo necessario a prendere la posizione, rimaniamo nel contesto della sollecitazione fisica? Tante. Forse troppe.
È un dato di fatto: nella nostra pratica di āsana siamo prevalentemente concentrati a mantenere la posizione nello sforzo piuttosto che cercare il rilassamento. Per quanto teoricamente sappiamo di doverla raggiungere, l’assenza di sforzo nella pratica non ci appare come una priorità e quindi ce ne dimentichiamo facilmente. Ma perché facciamo così? Per tanti motivi. In primo luogo forse non siamo pronti, né fisicamente né mentalmente, a tenere quella posizione. Abbiamo saltato il consiglio dei manuali di procedere per gradi.
Sostanzialmente siamo più abituati alla performance che alla meditazione, e di conseguenza portiamo nella pratica yoga abitudini ordinarie come la competizione, la sfida, la lotta e la ricerca di un risultato materiale. Ci viene più facile fare che lasciar andare.

È vero anche che l’assenza di sforzo apre la porta alla dispersione mentale che, mediamente, non sappiamo gestire. Quante volte nell’immobilità veniamo disturbati dal turbinare dei pensieri? Allora ci convinciamo che sia più utile praticare āsana difficili o dinamici, che impegnino fortemente il corpo e distraggano la mente. Tuttavia questa strategia si rivela presto fallimentare, proprio per via della natura stessa della mente operativa, che non è mai sazia. Lo sforzo da mettere in campo, semmai, sarebbe quello di attenuarla, magari dando più spazio alle pratiche più sottili, come prānāyamā, mudrā e mantra, che favoriscono il rilassamento e l’introspezione.
Dunque la corretta gestione dello sforzo in āsana passa per la costante consapevolezza, e per la conseguente capacità pratica, di allentare e dosare le tensioni necessarie alla tenuta della posizione, nell’ottica di aprirsi a una dimensione più profonda dell’esistenza. A quanto pare le teorie dei saggi upanisadici confermano la loro eterna validità, se lo sforzo essenziale da applicare a tutte le pratiche di āsana rimane ancora oggi quello di voler (e saper) passare dalla forma esterna alla vita interiore, dalla percezione sensoriale del corpo fisico all’esperienza intuitiva del corpo energetico.

Come gestire lo sforzo in āsana. Un suggerimento pratico
- Raggiunta la posizione, ammorbidiscila un pochino, prendendo coscienza dell’allentamento dello sforzo messo in atto per entrarvi.
- Chiudi gli occhi e cerca la stabilità e la comodità all’interno del corpo, dimenticando lo specchio, il confronto e la forma esteriore.
- Osserva se sono presenti tensioni nelle varie parti del corpo e se si attivano sforzi muscolari non necessari alla tenuta della posizione.
- Prova a scioglierle semplicemente prendendone coscienza. Deve rimanere attivo solo il minimo sforzo fisico necessario alla tenuta dell’āsana, cioè uno sforzo che non coinvolga il mentale e che non stuzzichi pensieri, desideri, emozioni. Esci dalla fretta, dalle aspettative, dall’ansia del risultato.
- Stai in āsana finché l’immobilità del corpo coincide con l’attenuarsi dei processi mentali egoici e vorticosi. A quel punto i riferimenti con l’esterno si attenuano fino a spegnersi quasi del tutto.
- Ora sei pront* per il salto nella dimensione sottile del respiro.
- Porta la coscienza sul ritmo del respiro spontaneo.
- Poi inizia a ripetere il mantra ham! sa! e introduci le due pause dopo l’inspiro e dopo l’espiro.
- Se stai praticando correttamente i confini del corpo fisico appariranno alla tua coscienza sempre più sfumati e contemporaneamente sentirai la mente alleggerirsi e rimanere in uno stato di piacevole sospensione. Col perdurare dell’immobilità e dell’assenza di sforzo perderai ogni riferimento al tempo ordinario e allo spazio circostante, fino a sentirti totalmente immers* in un flusso di coscienza che si appoggia sul respiro, a questo punto divenuto impercettibile.
- Una particolare felicità pervade questo sereno raccoglimento, insieme alla profonda connessione che senti verso te stess*, tutti gli esseri viventi e l’universo intero.
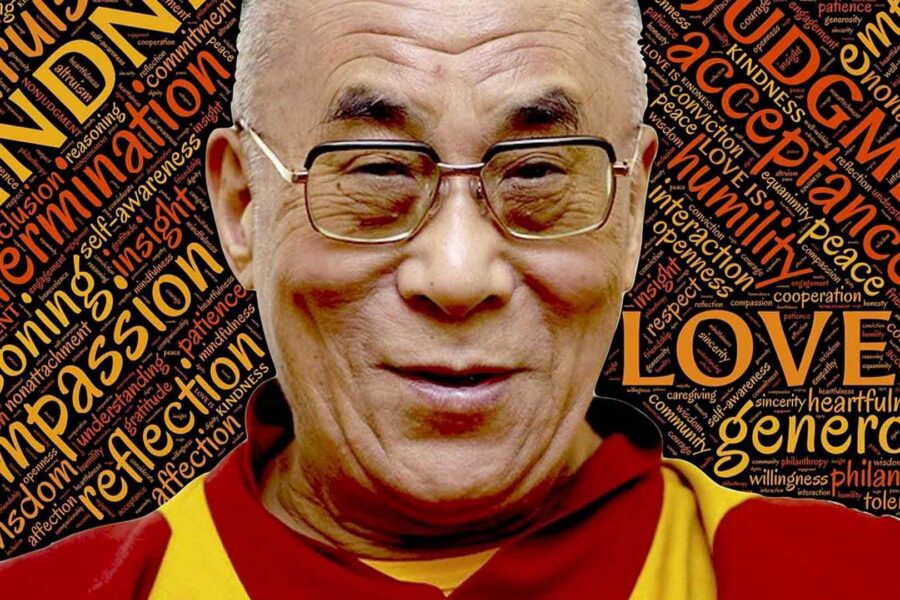
Il 6 luglio il massimo esponente buddhista spegne 90 candeline e svela il futuro della sua istituzione. Che è sempre più minacciata dal tentativo cinese di controllarne l'elezione. Un momento di grande apprensione perché potremmo ritrovarci con due Dalai Lama...

Da cento anni lo yoga moderno non ha fatto altro che ubriacarci di posture, abilità fisiche e contorsioni, spogliando la disciplina dalle sue radici spirituali e filosofiche. Sempre più insegnanti, pagine social e siti, promuovono uno yoga più legato ai testi antichi. Uno yoga che ritorna alle origini e insegna a ricercare l’immobilità in āsana, per raggiungere gli scopi più elevati. Tuttavia non bisogna mai “buttare il bambino insieme all’acqua sporca”...
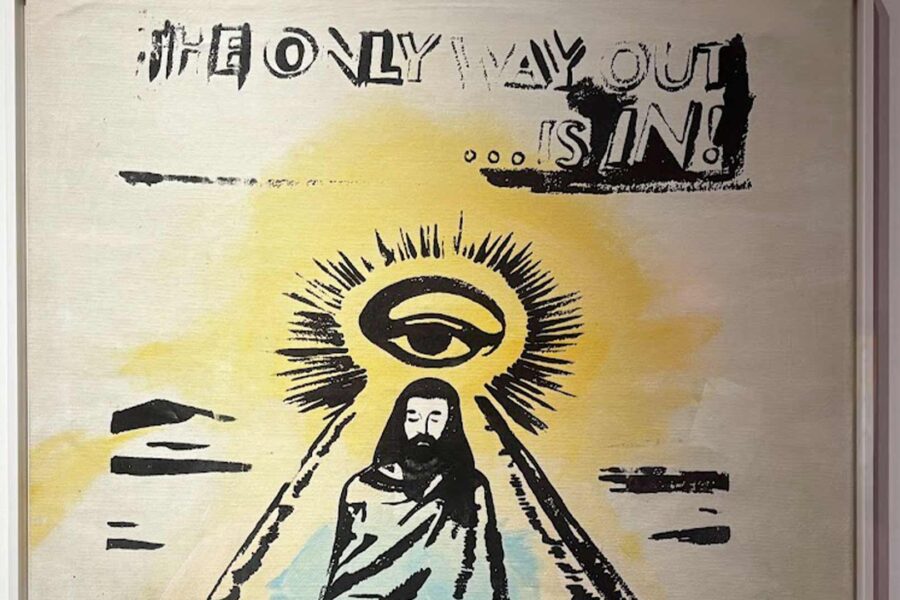
Molto spesso iniziamo un percorso spirituale per acquisire qualcosa: per diventare più buoni, più calmi, diversi da quell'immagine di noi che stride con le nostre illusioni. E se invece fosse necessario guardare da un'altra angolazione? Una meditazione per cambiare davvero...

Le Quattro Nobili Verità, cuore dell’insegnamento del Buddha, non parlano solo a monaci e meditanti. In questo articolo le “leggeremo” guidati da parole antiche e brani indimenticabili. Perché anche un verso o una melodia, a volte, possono far girare la ruota del risveglio

Il maestro Ramin Bahrami, 48 anni, qualche giorno fa al Teatro Antico di Taormina ha ricevuto un prestigioso premio al Taormina Book Festival, ma il suo cuore era con la mamma, 89 anni, che «era partita da poco per andare a trovare l’anziana sorella» E ha lanciato un messaggio di pace. Perché, dice «dobbiamo capire, che siamo parte di una partitura più grande di noi che deve produrre un fiore di bellezza»

L’idea che possano esistere altri mondi oltre il nostro ha da sempre acceso la fantasia di scrittori e lettori, diventando col tempo anche oggetto di speculazione scientifica. Tra letteratura e fisica teorica, il concetto di universi paralleli ha attraversato i secoli come un ponte tra immaginazione e conoscenza, trovando nuova linfa negli esperimenti più recenti, come quello condotto dall’antenna ANITA nei cieli dell’Antartide...





