Continuiamo a parlare della proliferazione degli āsana dello yoga in India, dai tempi di Patañjali a oggi. Nell’articolo precedente (clicca qui) abbiamo visto che in uno dei manoscritti dello Yogacintamani, di Sivananda Saraswati, compare una data precisa – il 1659 – e una lista di 84 āsana. Le posizioni non sono descritte nel dettaglio, ne viene fatto solo un elenco. Invece sono descritti dei kriya, che combinano tecniche di prānāyāma e āsana. Questo dimostra che dopo il 1600 le tecniche di hatha-yoga diventano più sofisticate. Per la prima volta, nel manoscritto Ujjain, molti di questi āsana compaiono in un testo scritto in sanscrito, mentre invece, alcuni erano già comparsi in un manoscritto persiano illustrato, il Bahr al Hayat, sempre di metà del 1600.
In questo manoscritto sono illustrati 22 āsana, di cui alcuni non seduti. Quindi sia il manoscritto Ujjain che questo testo persiano parlano dello stesso yoga che, per arrivare fino alla corte Moghul, dovrebbe essere stato in quel periodo molto in voga. Questo significa che, lungi dal cadere in declino, le tecniche di hatha vissero alla fine del ‘600 un grande momento di gloria, sotto il controllo di tanti bramini e “innovatori”, il cui lavoro deve aver reso l’hatha yoga più accessibile a un pubblico vasto ed erudito. Il professor Jason Birch, nel suo studio, ci offre la traduzione e la critica di un altro manoscritto, che dimostra la continua trasformazione ed evoluzione della pratica di āsana nello hatha-yoga del Seicento. Si tratta della versione estesa della Hathayogapradīpikā, che si chiama Siddhantamuktavali. Questo testo è composto da sei capitoli, contiene 1.553 versi – 1000 in più dell’HYP – 96 āsana e riporta, alla fine, una data: 1708. Purtroppo l’unico manoscritto ritrovato è rovinato, non è pubblicato e mancano dei fogli.
Successivamente Birch parla di un altro importante manoscritto, l’Hathabyashapaddhati, che inizia con il nome dell’autore, un certo Kapala Kurantaka; tenete in mente questo nome perché ci ritorneremo più avanti con uno scoop. Il manoscritto non è completo, mancano la data finale e il commento dello scriba. Probabilmente è del Settecento. Cos’è un paddhati? Un manuale, una serie di «istruzioni diverse, provenienti da vari testi, in un ordine che facilita la loro applicazione pratica». L’Hathabyashapaddhati non cita precedenti testi yoga e presenta la pratica in modo ordinato: yama, niyama, āsana, satkarman, prānāyāma e mudra. Finisce all’improvviso, come se fosse incompleto. Forse un tentativo incompiuto di ordinare un precedente testo in un manuale. La sezione sugli āsana descrive 112 posizioni (di cui molte inedite) e dà molto spazio alle illustrazioni. L’ordine di descrizione è la chiave per capire come praticare gli āsana, poiché ogni descrizione si basa su quelle precedenti, cioè bisogna padroneggiare ogni āsana prima di passare al successivo. Attenzione! Questo modus operandi sarà ripreso dai più importanti guru del ‘900. Quelli a cui molto spesso ci riferiamo.
Tornando a Birch, forse alcune posizioni illustrate nel manoscritto derivano dal wrestling e da altri sistemi di ginnastica indiani, ma il nome – Hathabyashapaddhati – indica che siamo nel campo dello yoga. Questo manoscritto dimostra molte cose. Intanto che gli hatha-yogin nel ‘700 praticavano āsana dinamici con l’uso di supporti e muri. Che agli āsana “classici” furono aggiunti āsana in movimento, e molte posizioni furono combinate a un movimento che si ripete più volte. Che gli āsana furono sistemati sequenzialmente: supini, proni, statici, in piedi, con corda, “che perforano sole e luna”. È il 1708, e siamo in presenza delle prime proto-sequenze e delle prime suddivisioni in gruppi degli āsana. Non so a voi, ma a me questa cosa affascina parecchio. Soprattutto perché talvolta parliamo della mercificazione dello yoga dando tutta la colpa alla società dei consumi (che le sue colpe le ha, mica no) dimenticando le precedenti, immani, responsabilità delle spoliazioni culturali operate dai grandi imperi coloniali.
Questo elemento ci può aiutare a capire perché ci fu questa evoluzione nello hatha-yoga. E perché andò nella direzione che conosciamo. Possiamo ipotizzare che durante il ‘700 gli āsana dello hatha-yoga furono riadattati, con l’inserimento di una gamma di intense posizioni e movimenti continui, allo scopo di coltivare forza e vigore. Questo, molto probabilmente, si era reso necessario per fronteggiare la superiorità fisica e la derisione dei soldati inglesi, che consideravano i maschi indiani deboli ed effeminati. I militari inglesi, dal canto loro, seguivano dei rigorosi protocolli ginnici, derivanti da sistemi di ginnastica callistenica europea (Ling, Mclaren, Bukh…), che a loro volta pescavano da antichi metodi cinesi… (che gran calderone!). È come se a un certo punto gli indiani si rivolsero agli invasori dicendo loro: «Ah sì? Noi abbiamo una disciplina antichissima, lo yoga! Ve lo facciamo vedere noi come si forgia un corpo». In sostanza lo hatha-yoga che arriva a noi nel ‘900 nasce, poche centinaia d’anni prima, per una botta d’orgoglio nazionalista e per un mix inestricabile di pratiche fisiche.
L’incremento nel tempo del numero di āsana dipese, però, anche da altri fattori.
Riepilogando: nel 1400 esistevano già 84 e più āsana, anche al di fuori delle tradizioni hatha, quindi è ipotizzabile che all’inizio fossero considerati elementi poco interessanti e poi, col tempo, la loro importanza crebbe. Questo accade probabilmente perché la popolarità dello hatha-yoga cresce esponenzialmente dal 1000 al 1600, trasformando lo hatha da pratica ausiliaria (uno di 4 yoga) a pratica a se stante. Bisognava avvicinarsi ai gusti di sempre più persone (ci ricorda qualcosa?) e quindi fu necessario introdurre sperimentazioni, innovazioni, contaminazioni da ascetismo e arti marziali. Molto prima degli inglesi si era, molto probabilmente, sviluppata una sorta di competizione fra le varie tradizioni. Ci furono sicuramente molti hatha-yogin “innovatori” (i cui nomi, si spera, verranno fuori nei prossimi studi), che idearono nuove posizioni e le loro combinazioni. Sarà interessante capire se lo scopo della pratica si evolvette alla stessa rapidità della pratica stessa, e se fosse esplicitamente espresso.

Un altro elemento chiave per la diffusione e la proliferazione degli āsana è rappresentato dallo sviluppo della letteratura dell’hatha-yoga. A un certo punto si scrive molto di più, e mentre i primi testi sono brevi, scritti dagli allievi per gli allievi, nel tempo diventano più estesi ed eruditi. Ma quali sono le connessioni fra gli āsana medievali e quelli moderni? Qui Birch tocca un punto cruciale. Visto che all’inizio del ‘900 i sistemi di yoga indiani prevedevano molti āsana, ci si può chiedere se i loro pionieri furono influenzati da qualcuno dei testi che abbiamo menzionato. Sicuramente sì, sebbene nessuno li citi. Li imparavano senza sapere le fonti, secondo il loro ancestrale modo di tramandare le conoscenze: “da bocca a orecchio”, la parampara. E per sovrapposizione. Forse i manoscritti che parlano di quelle cose sono stati mangiati dai topi, dall’umidità o sono sepolti in qualche polverosa biblioteca. Ma alcuni bramini possono aver ereditato quelle conoscenze delle loro famiglie o dai maestri perché molti contenuti emergono nei loro insegnamenti.
Krishnamacharya, Sri Yogendra, Kuvalayananda, per citare alcuni dei più importanti guru del ‘900, disapprovavano l’ascetismo estremo e le pratiche dei rinuncianti, come del resto fecero gran parte dei riformatori dello yoga. Ma allora le loro tradizioni a cosa si appoggiavano? Non c’è modo di capire, dalle loro biografie, a quali testi si riferissero nel loro insegnamento, sebbene sia assai probabile che attinsero da fonti hatha del XVII secolo come lo Yogacintamani e le Yoga-Upanisad. Questo si capisce dal fatto che menzionano posture sedute, flessioni in avanti e indietro, rotazioni e posizioni di equilibrio.
Per quanto riguarda i nomi degli āsana la confusione regna sovrana. Ci sono moltissime differenze fra tradizioni dello stesso periodo e tradizioni moderne. A parte la lista di āsana del Pātanjalayogaśāstra, che viene presa come fonte di credenziale da vari lignaggi (come avviene oggi, il che è un paradosso perché probabilmente è un’aggiunta tardiva e per certi versi posticcia), tutti gli āsana hanno nomi diversi. Ma perché? Per via di influenze locali e perché i vari guru tentavano di differenziare il loro repertorio da quello degli altri (oggi si chiamerebbe brandizzazione). Pensate cosa avrebbero fatto ai tempi di Instagram.
Altre cose che gli studi di Birch evidenziano
Le pratiche del “Saluto al sole” e i “Vinyasa” non ci sono nei testi medievali. Sono invenzioni moderne. L’Hathabyashapaddhati descrive āsana in movimento e sequenze, ma non dice come praticarli, né per quanto tempo tenerli o come respirare. Questo significa che, allora come oggi, è come il maestro conduce la lezione a fare la differenza, a parità di “illustrazioni”, testi o contenuti. Non c’è modo di capire se la fase dinamica fosse a servizio di una posizione statica finale da tenere a lungo, come la tradizione di Patañjali suggerisce nei suoi intenti. O come la risalita energica dell’energia kundalinī fosse compatibile con una fase di profonda meditazione, che presuppone una stasi, giacché i gradini dell’hatha corrispondono a quelli del rāja-yoga.
Altri elementi
Sia nello yoga medievale che in quello moderno ci sono posizioni invertite. Nel primo canone hatha le inversioni sono una mudrā, chiamata viparita karani. Nel tardo hatha diventano un āsana, con appoggio (più o meno marcato) sulla testa, nelle varianti kapalāsana, sirsāsana, sarvangasana. L’applicazione delle mudrā negli āsana non seduti, non è medievale, ma moderna. Molti āsana in piedi dello yoga moderno derivano dai sistemi di ginnastica portati dagli inglesi, e non dall’hatha medievale. Non è ancora molto chiaro come, ma sembra che il wrestling indiano e le tradizioni marziali possano aver ispirato molti degli āsana moderni in piedi.
Krishnamacharya era familiare con i 112 āsana dell’Hathabyashapaddhati, perché aveva letto la Sritatattvanidhi, che viene citata nel suo testo: Yogamakaranda. Nel suo sistema le posizioni in piedi sono preminenti. Nelle sue varie biografie non è chiaro se conoscesse la provenienza dei testi che cita. Si dice che i suoi insegnamenti derivino da un fantomatico testo denominato Yoga Kurunta, conosciuto dai suoi allievi. Ma nessuno ne ha mai avuto in mano una copia e nessun catalogo di manoscritti indiani riporta un testo con questo nome (come evidenziato anche da Mark Singleton). Eppure anche la tradizione di Iyengar fa risalire l’uso delle corde nella pratica a questo testo. Ma allora questo fantomatico Yoga Kurunta non potrebbe essere un altro nome di quel testo redatto da tale Kapala Kurantaka, cioè l’Hathabyashapaddhati? E come mai nessun esponente di queste tradizioni ha mai fatto questa associazione? Forse qui su Rispirazioni stiamo aggiungendo un tassello alla storia dello hatha yoga…
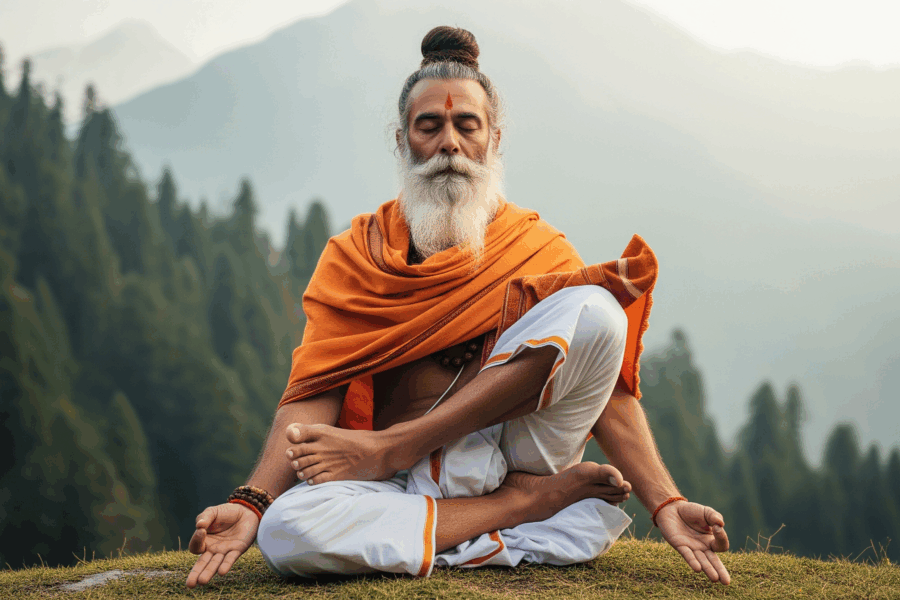
Gli ultimi studi dicono che gli hatha-yogin nel ‘700 praticavano āsana dinamici con l’uso di supporti e muri. Che agli āsana “classici” furono aggiunti āsana in movimento, e molte posizioni furono combinate a un movimento che si ripete più volte. Tra il 1000 al 1600 lo hatha si è trasformata da pratica ausiliaria (uno di 4 yoga) a pratica a se stante. Bisognava avvicinarsi ai gusti di sempre più persone e quindi fu necessario introdurre sperimentazioni, innovazioni, contaminazioni da ascetismo e arti marziali. E molto prima degli inglesi si era, molto probabilmente, sviluppata una sorta di competizione fra le varie tradizioni...

Il racconto di una sosta in un parco, la scoperta di un piccolo grande paradiso. I gesti di un'anima in ricerca, il gusto di trovare il bello in quello che c'è. Sempre...

Il primo monaco induista approdato negli Stati Uniti nel 1893 scrisse parole sorprendenti sulla religione “sorella” dell'induismo. «Lungi da me l’idea di criticare il Budda, visto che io l’adoro come Dio incarnato!», diceva. In India infatti Shakyamuni è una delle 10 incarnazioni di Visnu. Per lui, dunque, non sarebbe stato un fondatore di una nuova religione, ma piuttosto un continuatore del cammino tracciato dai Veda...

Krishna è chiaro: non è possibile non agire, a meno di non essere morti. Perché è nell’azione che l’essere umano esprime il proprio amore. L’azione è parte integrante della vita. Ma Krishna non parla solo di azione fisica, cioè di come muoviamo il corpo, bensì soprattutto di azione “sottile”, ovvero del movimento interiore, mentale, emozionale — che, secondo la visione vedica, è ancora materia, e non è l’anima...

...ma noi qui vi spieghiamo tutto quello che è necessario sapere per scoprire come nei Veda il calcolo del tempo sia uno dei temi di sfondo, con incredibili interconnessioni ai principali significati filosofici. Nel «Bhagavatam» si sostiene che sia possibile calcolare il tempo misurando il movimento degli atomi che si combinano nel corpo; il tempo atomico si misura calcolando lo spazio atomico preciso che esso ricopre...






