Qualche giorno fa ho letto un interessante articolo intitolato «Gli sciamani non ci salveranno» e sono rimasta incuriosita, più che dal titolo, dal sommario: «Contro l’appropriazione indebita dello sciamanesimo». L’articolo è una conversazione fra due antropologi di chiara fama, i quali concordano su vari punti, primo fra i quali: l’Occidente si è appropriato delle pratiche sciamaniche, mercificandole e banalizzandole.
Da una parte siamo spinti a cercare forme di spiritualità alternative, poiché le risposte dell’Occidente sono insufficienti a rispondere alle domande esistenziali, dall’altra non facciamo che modellare queste proposte al nostro ego, creandoci a volte delle religioni “fai-da-te”.
Da un lato siamo affascinati dalla lezione di ecologia che ci danno i nativi, cioè che l’uomo non è separato dall’ambiente, che non è un dominatore, ma un elemento interconnesso agli altri da una fitta rete di relazioni, e dall’altro continuiamo a comprare sciocchezze su Amazon, senza porci mai il problema della nostra responsabilità personale nei confronti dell’ambiente.
In preda a una grande confusione intraprendiamo perfino degli «sciamanic tour», nei quali andiamo a visitare gli sciamani nel loro habitat e assistiamo ai loro rituali, ovviamente depurati da ogni elemento cruento, violento e sacrificale. Ci tatuiamo simboli nativi senza sapere nulla del significato di quel segno all’interno della storia di quel popolo.
In sostanza lo sciamanesimo è l’ultimo grande frullato di contraddizioni e mistificazioni che beviamo, credendo di placare la sete della ricerca del senso della vita.
Cito testualmente l’antropologo Stefano De Matteis: «La particolarità dello sciamanesimo che ho incontrato in Italia sta nel fatto che offre una via di salvezza dagli orrori del mondo unicamente nell’affermazione del Sé, nelle strategie individuali di miglioramento e nell’esaltazione di un individualismo che non si confronta con l’altro, vicino lontano che sia. Che non mette in atto nessuna pratica collettiva e condivisa…». Ecco, questo è il punto che ha acceso un mio pensiero: tutto quello che stiamo facendo allo sciamanesimo lo abbiamo già fatto allo yoga.
Non è forse vero che, oggi, lo yoga è vissuto prevalentemente come una disciplina a servizio dell’auto esaltazione e della forma esteriore? Sono ridotte al lumicino quelle realtà in cui si leggono i testi fondanti e si approfondiscono certe tematiche, e in cui la pratica non è fatta al 100% di asana.
Ma questa è una degenerazione che viene da lontano e, per certi versi, è stata causata da insospettabili agenti. Per esempio: nell’800 gli yogin furono portati dagli inglesi in Europa, nelle fiere del culturismo, per essere ammirati dalle folle, fra stupore e ribrezzo. Molto spesso gli occidentali hanno tradotto i testi sacri dello yoga per vantaggi personali e per dimostrare le proprie tesi. Nel corso del “rinascimento indiano”, alcuni intellettuali indiani hanno tagliato o censurato diversi contenuti testuali, perché l’occidente li avrebbe reputati offensivi e ripugnanti. Nei primi anni del ‘900 lo yoga portato in Europa e in America fu edulcorato da alcuni guru, per renderlo digeribile alle platee cattoliche e protestanti. E poi, da tutti, fu esaltata la forma: asana, asana, asana a più non posso.
Il tema dell’appropriazione culturale è complesso e per analizzarlo in profondità è necessario capire come funzionano le dinamiche di potere internazionali, perché alla base del fenomeno c’è sempre una cultura “superiore” che ne sfrutta una povera e fragile. A volte fino a cancellarla.
Oggi c’è più consapevolezza del riguardo che dovremmo avere nei confronti di culture distanti dalla nostra, eppure un po’ tutti cadiamo in certe trappole che il consumismo opportunamente cavalca.
E allora come fare per non essere, anche inconsapevolmente, complici di questo impoverimento? Una strada possibile è quella di impegnarsi ad andare più a fondo, a non essere superficiali nei confronti delle culture lontane.
Studiamo il significato dei mantra invece di ripeterli a pappagallo, studiamo la storia dello yoga per capire cosa vuol dire āsana o meditazione, approfondiamo, compriamo libri, confrontiamoci con altri yogin o con i maestri. Creiamoci un efficace sistema immunitario fatto di conoscenze che ci protegga dalle bufale e dai sedicenti swami e sciamani. Aprendosi alla conoscenza, la nostra pratica cambierà, e tratteremo lo yoga- e lo sciamanesimo- col rispetto dovuto a questi grandi maestri di vita.

Il sistema delle caste in India è uno dei fenomeni sociali più antichi e complessi al mondo e affonda le sue radici nei testi religiosi dell’induismo. Nonostante i progressi legislativi, nella pratica le discriminazioni castali non sono scomparse. E anche se il peso elettorale degli “intoccabili” serve al potere, i loro diritti sono pochi e il cammino verso una piena uguaglianza rimane lungo e complesso...

Lo Yoga è patrimonio dell’umanità come lo sono le grandi religioni, il pensiero di Socrate e Platone e le canzoni di Bob Dylan e dei Beatles. Fa parte del nostro immaginario e ha dato all’uomo – non solo all’uomo indiano hindu – una via di liberazione dalle sofferenze. Ecco perché lo celebro sul palco dell'Arena di Milano...

Il primo ministro Modi che ha voluto questa “festa” è la persona meno adatta a parlare di yoga perché il suo governo e il suo partito sono repressivi, violenti e irrispettosi dei diritti umani. Io non ci sto: sono profondamente convinta che lo yoga non sia un proclama di intenti, ma uno stato d’essere, una esperienza personale di chi ha trovato in questa disciplina uno strumento per vivere con più equilibrio e serenità la vita quotidiana
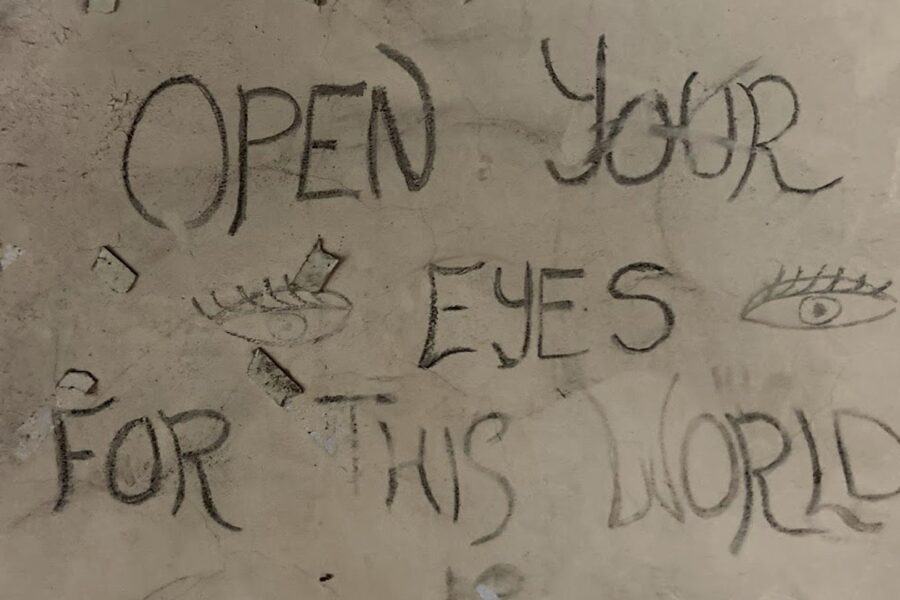
Dice Swami Niranjanananda, erede di Satyananda: «Il secondo capitolo dello Yoga è una nuova visione dello Yoga, non come pratica, ma come vidya, una saggezza che va compresa, assimilata ed espressa nella vita». E poi ancora «risvegliare e integrare le facoltà di testa, cuore e mani». Qualcosa si muove nel mondo di questa via spirituale, non più con l'obiettivo di un corpo flessuoso, ma di una vita integrata. Ed era ora

Nell’agosto del 2022, a pochi mesi dalla morte di mio padre, decisi di ripercorrere le orme del principe Siddhartha Gautama. Il suo percorso, come sappiamo, culminò con l’“illuminazione”. Il mio è stata un'immersione nella sua spiritualità e nei luoghi che lui toccò. Un'emozione che vi racconto a parole e con le mie immagini
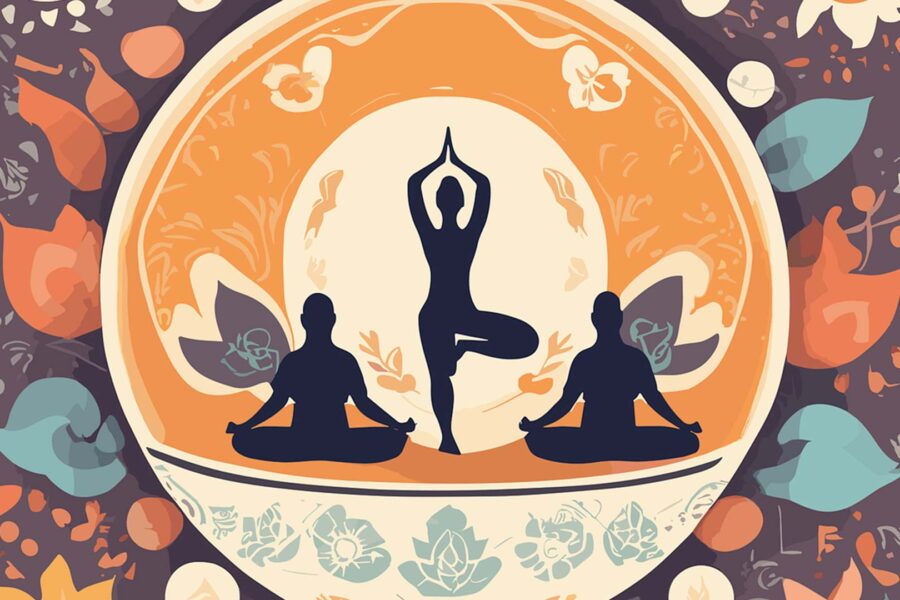
Quando si parla di testi della tradizione Hatha, di solito si menzionano la «Siva Samhita», la «Gheranda Samhita» e l’«Hatha Yoga Pradipika». Ma nelle biblioteche indiane giacciono migliaia e migliaia di manoscritti in attesa di essere tradotti. Gli esperti sono pochi e quindi ci vuole tempo. Da poco, per esempio, è stato scoperto e tradotto un altro testo, l'«Amṛtasiddhi», tradotto da James Mallinson, e a sua volta tradotto in italiano dalla nostra Amalia Cornale





