Una delle caratteristiche peculiari degli Yogasutra di Patanjali è quella secondo cui ogni volta che li rileggiamo ne scopriamo nuovi significati e prospettive. Succede perché siamo noi a cambiare, a trasformarci. Succede perché stiamo cercando ulteriori risposte alla solita domanda: perché soffro? Perché questo dolore esistenziale non mi dà tregua, malgrado tutti gli accorgimenti che metto in campo?
Lo Yoga proposto da Patanjali mira all’eradicazione di quest’angoscia primaria partendo dalla necessità di purificare la percezione, il modo di pensare, il modo in cui vediamo la realtà che ci circonda. Yogasutra si occupa prevalentemente della mente, di come è fatta e del perché reagisce in un certo modo anziché in un altro.
Solo dopo aver capito in dettaglio come funzionano i nostri processi mentali abbiamo una chance per poter allontanare l’angoscia e stare meglio, specie se riusciamo a seguire il suo asthtangayoga, un metodo fatto di prescrizioni, posizioni e respirazioni che ci portano verso lo stato meditativo, dissipano il potenziale distruttivo dei klesa, vaporizzano le angosce, ci donano la pace.
Ma che facciamo quando viene a trovarci l’emicrania o la colite? Quando il reflusso gastroesofageo mette in secondo piano la paura di morire? Dov’è Patanjali quando il gioco si fa duro ed è il corpo a dolere?
In realtà Patanjali, oltre a essere l’autore del trattato che cura la mente (Yogasutra), è anche un medico che cura il corpo. Secondo alcune tradizioni è lui l’autore della Caraka Samhita, il testo fondamentale dell’Ayurveda, la scienza medica indiana, in cui vengono trattati diversi temi riguardanti la struttura esterna dell’uomo: il corpo e i suoi involucri.
Ai maestri del Samkhya e dell’Ayurveda interessava investigare il corpo in funzione del progetto della liberazione finale. La buona salute della mente e del corpo erano considerati requisiti indispensabili per poter sfuggire al mondo e liberarsi definitivamente dal ciclo delle nascite e delle morti.
Secondo le basi filosofiche del tempo il dolore fisico era considerato una variante del dolore spirituale. Entrambi frutto dell’ignoranza, delle norme salutari il primo, e della natura autentica delle cose il secondo.
Anche nel caso del corpo ciò che nuoce, e fa ammalare, è lo squilibrio, la disarmonia, l’eccesso di alcune cose: «Come il baco da seta tesse i fili che lo condurranno alla morte, così l’ignorante sempre malato crea la sua sete a partire dagli oggetti».
Siamo fuori dal dominio vedico, non sono più gli Dei a determinare, con la loro collera o la loro benevolenza, la nostra salute, ma i nostri atti, passati e presenti, giusti o sbagliati. Secondo il testo quando il sintomo si manifesta sul corpo vuol dire che abbiamo già agito «escludendo la discriminazione, la volontà e la memoria», e generato prajnaparadha, «l’errore dell’intelletto», la causa eziologica di tutti i nostri malanni.
Ci ammaliamo fisicamente perché si è creato uno squilibrio nei nostri componenti di base: vata, pitta e kapha. Che non sono altro che il riverbero di ciò che avviene a monte: l’incessante e corrosivo altalenare fra raga e dvesa, rajas e tamas, la dualità del divenire che ci strazia.
Nella Caraka Samhita ritroviamo la carezza educatrice di Patanjali che, con parole simili a quelle usate in Yogasutra, questa volta ci mette in mano le chiavi della nostra salute fisica: «Il conoscitore, sapendo che gli oggetti [dei sensi] sono come fuoco, si ritira da essi. Poiché non intraprende azioni e non si congiunge [con gli oggetti dei sensi] egli non si espone al dolore».
Nel trattato si parla di parti del corpo, di embrioni, di malattie stagionali, ma alla fine è sempre la qualità della mente che fa la differenza fra sukham e duhkham, salute e malattia.
Il perché è presto detto: è la mente il fattore di collegamento fra il sé vivente e il corpo senziente. Tutto, perforza di cose, deve passare da lì.
È il tipo di mente che abbiamo ereditato a livello karmico – stabile, pura, instabile, passionale, indolente, scura – che ci rende individui sani o malati. Ma è anche il modo in cui agiamo in questa vita che può fare qualche differenza. Nel trattato se ne parla ampiamente:
«Le malattie non affliggono colui che ha soggiogato i propri sensi, a meno che non sia giunta l’ora voluta dal destino».
«Le malattie non affliggono colui i cui pensieri, parole, ed azioni recono buone conseguenze, la cui mente è sottomessa, che possiede un intelletto puro, conoscenza, ardore ascetico e dedizione allo yoga».
«Non si ammala colui che segue un regime dietetico e comportamentale salutare, che agisce dopo aver riflettuto, che non è attaccato agli oggetti dei sensi, che dona, che è equanime sincero e tollerante e che frequenta i saggi».
Il rigore di queste prescrizioni è disarmante. Ma non ci stupisce: conosciamo Patanjali, non è tipo da rimedi sintomatici. Con lui si va alla fonte del problema, oppure si continua a mentire a se stessi, aumentando il disagio.
Ci sentiamo eroici le volte in cui, malgrado viviamo in un mondo così complicato e condizionante, riusciamo a mettere in pratica i suoi consigli. Ma questo non ci esenta dalla colite e dall’emicrania. Puntualmente il nostro sgradito malessere ritorna a trovarci e, malgrado il tanto yoga, ci tormentiamo con le solite domande: dove ho sbagliato? Perché è tornato? Cosa non ho visto arrivare? Come faccio a farlo passare? Il risultato è il caos.
Col dolore fisico la mente va in tilt, esattamente come quando in asana si è travolti dallo sforzo.
Cosa possiamo fare allora per sfruttare l’insegnamento di Patanjali anche in questo frangente? Possiamo scavalcare, per quanto possibile, il dolore e continuare a indagare su noi stessi, imparando a guardare i nostri malesseri cronici da altre prospettive.
In prima battuta possiamo contestualizzarli come frattali che si ricreano incessantemente nell’ambito di una cornice familiare, questo li depotenzia come sciagure capitate solo a noi.
Poi, più “yogicamente”, possiamo attuare un lavoro di affinamento della percezione verso i corpi più sottili, fino a riuscire a distinguere i disagi che sentiamo dipendere dalle insondabili pieghe dell’inconscio e dai samskara, spacchettandoli da ciò che, banalmente, dipende dalla nostra alimentazione, da un’arrabbiatura o da abitudini malsane.
Possiamo convincere noi stessi che certi dolori vengono da troppo lontano e non ne siamo responsabili. Né possiamo fare nulla per risolverli.
È un approccio interessante quello di raffinare la nostra percezione del dolore fisico per intuire ciò che possiamo modificare e distinguerlo da ciò che invece non è in nostro potere controllare.
Da questa discriminazione può emergere una nuova visione del corpo che fa male e un nuovo modo di avvicinarsi al dolore fisico. La pace che deriva dal lasciar andare ciò che non dipende da noi raggiunge l’anima, e cura più efficacemente di tante medicine e attività il nostro prezioso corpo.

Il sistema delle caste in India è uno dei fenomeni sociali più antichi e complessi al mondo e affonda le sue radici nei testi religiosi dell’induismo. Nonostante i progressi legislativi, nella pratica le discriminazioni castali non sono scomparse. E anche se il peso elettorale degli “intoccabili” serve al potere, i loro diritti sono pochi e il cammino verso una piena uguaglianza rimane lungo e complesso...

Lo Yoga è patrimonio dell’umanità come lo sono le grandi religioni, il pensiero di Socrate e Platone e le canzoni di Bob Dylan e dei Beatles. Fa parte del nostro immaginario e ha dato all’uomo – non solo all’uomo indiano hindu – una via di liberazione dalle sofferenze. Ecco perché lo celebro sul palco dell'Arena di Milano...

Il primo ministro Modi che ha voluto questa “festa” è la persona meno adatta a parlare di yoga perché il suo governo e il suo partito sono repressivi, violenti e irrispettosi dei diritti umani. Io non ci sto: sono profondamente convinta che lo yoga non sia un proclama di intenti, ma uno stato d’essere, una esperienza personale di chi ha trovato in questa disciplina uno strumento per vivere con più equilibrio e serenità la vita quotidiana
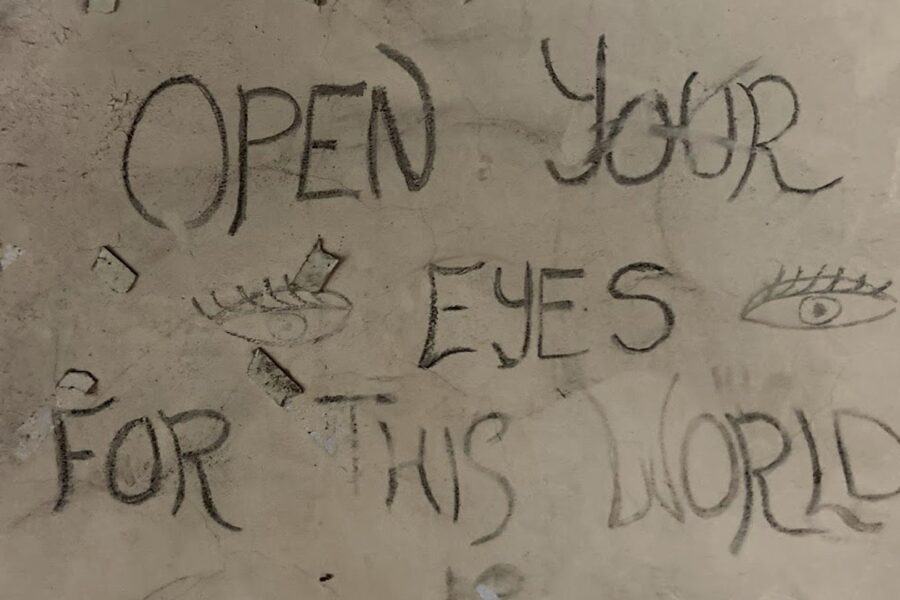
Dice Swami Niranjanananda, erede di Satyananda: «Il secondo capitolo dello Yoga è una nuova visione dello Yoga, non come pratica, ma come vidya, una saggezza che va compresa, assimilata ed espressa nella vita». E poi ancora «risvegliare e integrare le facoltà di testa, cuore e mani». Qualcosa si muove nel mondo di questa via spirituale, non più con l'obiettivo di un corpo flessuoso, ma di una vita integrata. Ed era ora

Nell’agosto del 2022, a pochi mesi dalla morte di mio padre, decisi di ripercorrere le orme del principe Siddhartha Gautama. Il suo percorso, come sappiamo, culminò con l’“illuminazione”. Il mio è stata un'immersione nella sua spiritualità e nei luoghi che lui toccò. Un'emozione che vi racconto a parole e con le mie immagini
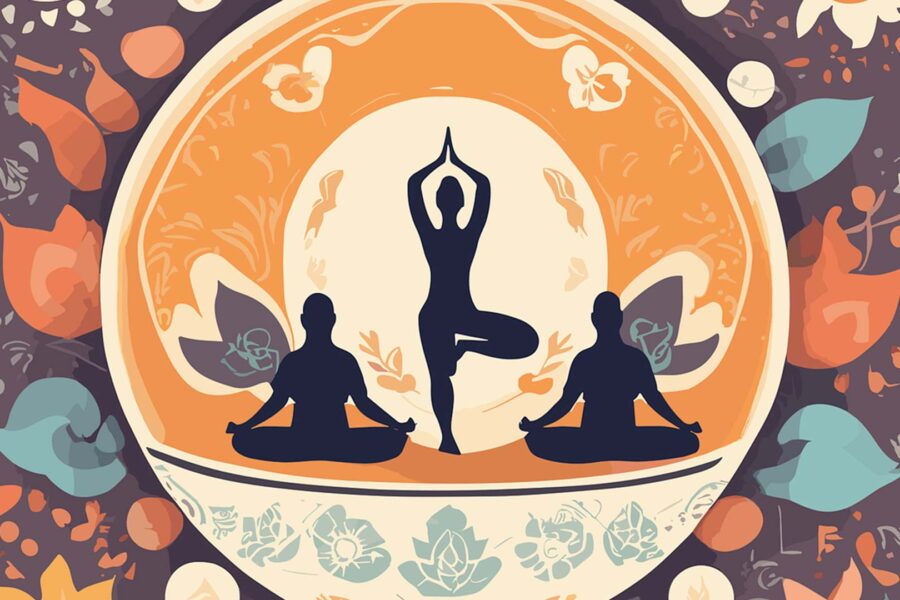
Quando si parla di testi della tradizione Hatha, di solito si menzionano la «Siva Samhita», la «Gheranda Samhita» e l’«Hatha Yoga Pradipika». Ma nelle biblioteche indiane giacciono migliaia e migliaia di manoscritti in attesa di essere tradotti. Gli esperti sono pochi e quindi ci vuole tempo. Da poco, per esempio, è stato scoperto e tradotto un altro testo, l'«Amṛtasiddhi», tradotto da James Mallinson, e a sua volta tradotto in italiano dalla nostra Amalia Cornale





