Yogacittavrittinirodha. Chi non conosce a memoria il secondo aforisma degli Yogasutra di Patañjali? Per gli insegnanti e i praticanti di Yoga è come un tatuaggio inciso nella mente. Dopo aver definito, col primo sutra, l’argomento del suo libro, Patañjali ci dice a cosa serve lo Yoga, qual è lo scopo dei restanti 193 aforismi. E per farlo unisce tre parole citta, vritti e nirodha in un connubio che segnerà per sempre la storia dello Yoga.
Si sa che dal libro Raja Yoga di Swami Vivekananda in poi, salvo rare eccezioni, gli Yogasutra sono stati tradotti e commentati in maniera libera, senza tenere conto della complessità e delle regole del commento classico. Dal guru più autorevole all’autodidatta.
Se paragoniamo le innumerevoli traduzioni delle parole: citta, vritti e nirodha ci perdiamo. Alla fine non sappiamo più a chi credere, e cosa voglia dire veramente la più famosa frase di Patañjali.
Per esempio le vritti sono: increspature, onde, turbini, vortici, fluttuazioni, funzioni, modificazioni, attività che, almeno su questo c’è unanimità, riguardano il piano mentale. Nirodha è: soppressione, restrizione, arresto, inibizione, spegnimento, cessazione definitiva.
E citta? Citta è tradotta come mente, coscienza, plesso della cognizione, psichismo, mentale. Ma mentre i significati di vritti e nirodha più o meno convergono, nel caso di citta spesso ci troviamo davanti traduzioni che danno significati completamente diversi tra loro. Per esempio: mente e coscienza. Sono concetti enormi, e sicuramente non sono sinonimi.
Quali sono i riferimenti testuali più antichi della parola citta? Nel Samkhya, la filosofia analitica su cui si appoggia lo Yoga, non è espresso il termine citta anche se il suo significato è sottinteso. Il Samkhya riprende ed elabora concetti già presenti nei Veda e nelle Upanisad.
A parte vi è Purusa, non creato-non creatore, conoscitore del campo (ksetrajna), testimone inattivo, pura Coscienza.
La presenza di Purusa rende manifesta Prakriti, da cui emerge buddhi, l’intelletto, la volontà, la potenzialità.
Da buddhi si origina ahamkara, il senso dell’Io, che a sua volta crea manas, la mente che ci collega ai sensi, al mondo fenomenico.
Seguono gli organi di senso, di azione, gli elementi sottili e quelli grossolani. Questi sono i 25 tattva, gli elementi che compongono ogni cosa.
Nello Yoga invece citta è un termine molto usato. Patañjali spesso lo fonde insieme a vritti, e crea il termine cittavritti, che Federico Squarcini nella sua traduzione di Yogasutra chiama «il vorticoso plesso delle cognizioni».
Cosa intendeva Patañjali con citta? Il “contenitore” di buddhi, ahamkara e manas? Secondo me sì. E per nirodhizzarlo completamente ci fa lavorare su manas tramite āsana, su ahamkara col prānāyāma, e su buddhi coi rami più interni dello yoga.
Ma questa “scatola” non è inerte. È interattiva, come ci spiega lo storico delle religioni David Gordon White. Citta per lui, «è la materia di cui è fatta la mente».
Patanjali considera l’universo e la mente dell’uomo secondo la concezione del Samkhya, cioè come realtà in perenne trasformazione, a causa dell’instabilità dei loro componenti di base (tattva); la materia, Prakriti, di cui tutto il mentale è composto, si mette in movimento allo scopo di liberare il Purusa (lo spirito) dalla sua errata identificazione col mondo fenomenico, e salvare l’uomo dal ciclo delle rinascite. Prakriti mette in atto una speciale danza, per stimolare il Purusa a vedere che esso non è parte dello spettacolo che sta osservando, ma è uno spettatore. In questo modo il Purusa capisce di essere una realtà a parte (kaivalya).
Sempre secondo White: «In tutto questo, il ruolo di quello che Patañjali chiama citta è fondamentale. Perché citta non è solamente la più immediata interfaccia fra il purusa e il resto dell’universo, ma è lo specchio in cui lo spettatore si vede. Questo specchio è uno specchio speciale, uno specchio che si deforma come il fluido di Terminator 2, che cambia forma e qualità costantemente. Queste fluttuazioni sono il risultato delle continue trasformazioni della mente agli stimoli sensoriali, alle passioni, alle emozioni, ai ricordi. Queste sono le cittavrtti della definizione di Patañjali. (…) con il metodo di Patañjali il praticante dello Yoga riesce a estraniare il suo pensare dal mondo fenomenico che lo rende instabile, legato ai bassi strati della materia, e viene portato alla visione del Sé. In questo modo citta (la materia della mente) diventa man mano più sottile, stabile ed espansiva. E quando il samadhi è raggiunto, citta si espande verso i più lontani angoli dello spazio e scompare dalla vista. Allora lo spettatore, non più soggetto agli effetti distorti di citta, diventa consapevole del suo isolamento dalle attività del mondo materiale, e “dimora nella sua forma propria”. Ciò determina la cessazione di ogni duhkha, di ogni sofferenza dell’esistenza».
Tutti i grandi guru hanno descritto citta durante le loro lezioni e nei loro libri. A differenza di quanto possiamo fare con gli accademici però, se citiamo le loro definizioni estrapolandole dal contesto testuale, corriamo il rischio di svilire il loro messaggio generale e di non comprendere cosa realmente intendono con quei termini. Per esempio per Swami Sivananda: «…Manas, buddhi e ahamkara sono aspetti funzionali della mente. […] E quando la mente esercita la volontà e il dubbio è chiamata manas, quando discrimina e decide è chiamata buddhi, e quando afferma se stessa e ahamkara. Quando funge da magazzino dei samskara, e sede della memoria, è il citta, e lo stesso quando pratica la concentrazione e la ricerca spirituale».
Per Swami Niranjanananda: «…Ahamkara, buddhi, citta e manas sono forme di Sakti, il potere primordiale. Sono agenti dell’Energia creatrice. La mente ha tre funzioni: in primo luogo si presenta sotto forma di coscienza, dove la sua funzione è conoscere, apprendere le cose. In secondo luogo agisce in quanto Prana Sakti sottile, in terzo luogo come indriya, costituisce un senso che ha per funzione la messa in relazione del mondo interno con il mondo esterno».
Sempre secondo Swami Niranjanananda: «…Occorre accordare la vita come se fosse uno strumento musicale dotato di quattro corde, queste quattro componenti sono manas, buddhi, citta e ahamkara: razionalità, intelligenza, ricordi e identità dell’io».
A me piace considerare citta come l’involucro di tutto il mentale, l’insieme delle tante facoltà mentali sparse in tutto il corpo, che lavorano a diversi livelli. Quando siamo in modalità “pilota automatico” (ahimè, per una buona parte della giornata) viaggiamo sulla barca dei samskara e stiamo attivando manas, la mente legata agli stimoli sensoriali più materiali. Finché restiamo confinati nella modalità di pensiero che reagisce all’impatto che il mondo ha su di noi questa “scatola” non si apre. Appena subentra una volontà, un tapas, e l’individuo imprime al suo pensiero una direzione verso una consapevolezza più elevata, si accende ahamkara e, anche se siamo sempre guidati dai samskara, abbiamo “rotto la bolla”. Quando infine riusciamo, anche grazie allo yoga, a superare questi due livelli, oltrepassiamo la barriera dell’immanenza. Siamo come un razzo lanciato nello spazio che ha dovuto, con un notevole dispendio di carburante, attraversare gli strati più densi dell’atmosfera. Raggiunta l’esosfera ecco buddhi, la qualità della materia più sottile, raffinata e vicina al divino. A quel punto siamo liberi, citta si separa dalle vritti, la “scatola” si apre e si espande verso l’infinito. Non c’è più corpo, né mente, né tempo, né spazio, solo la pura visione e l’unione con la trascendenza.

Il sistema delle caste in India è uno dei fenomeni sociali più antichi e complessi al mondo e affonda le sue radici nei testi religiosi dell’induismo. Nonostante i progressi legislativi, nella pratica le discriminazioni castali non sono scomparse. E anche se il peso elettorale degli “intoccabili” serve al potere, i loro diritti sono pochi e il cammino verso una piena uguaglianza rimane lungo e complesso...

Lo Yoga è patrimonio dell’umanità come lo sono le grandi religioni, il pensiero di Socrate e Platone e le canzoni di Bob Dylan e dei Beatles. Fa parte del nostro immaginario e ha dato all’uomo – non solo all’uomo indiano hindu – una via di liberazione dalle sofferenze. Ecco perché lo celebro sul palco dell'Arena di Milano...

Il primo ministro Modi che ha voluto questa “festa” è la persona meno adatta a parlare di yoga perché il suo governo e il suo partito sono repressivi, violenti e irrispettosi dei diritti umani. Io non ci sto: sono profondamente convinta che lo yoga non sia un proclama di intenti, ma uno stato d’essere, una esperienza personale di chi ha trovato in questa disciplina uno strumento per vivere con più equilibrio e serenità la vita quotidiana
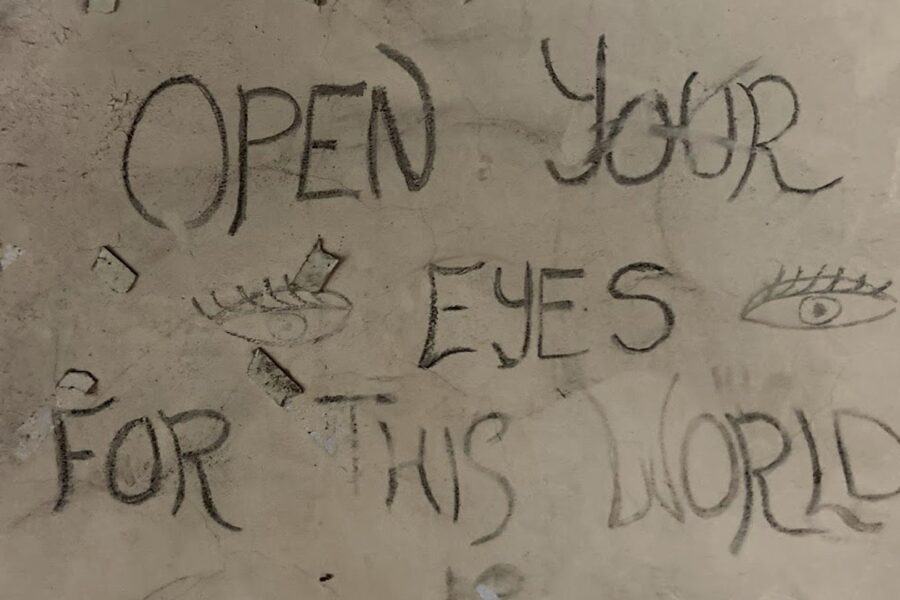
Dice Swami Niranjanananda, erede di Satyananda: «Il secondo capitolo dello Yoga è una nuova visione dello Yoga, non come pratica, ma come vidya, una saggezza che va compresa, assimilata ed espressa nella vita». E poi ancora «risvegliare e integrare le facoltà di testa, cuore e mani». Qualcosa si muove nel mondo di questa via spirituale, non più con l'obiettivo di un corpo flessuoso, ma di una vita integrata. Ed era ora

Nell’agosto del 2022, a pochi mesi dalla morte di mio padre, decisi di ripercorrere le orme del principe Siddhartha Gautama. Il suo percorso, come sappiamo, culminò con l’“illuminazione”. Il mio è stata un'immersione nella sua spiritualità e nei luoghi che lui toccò. Un'emozione che vi racconto a parole e con le mie immagini
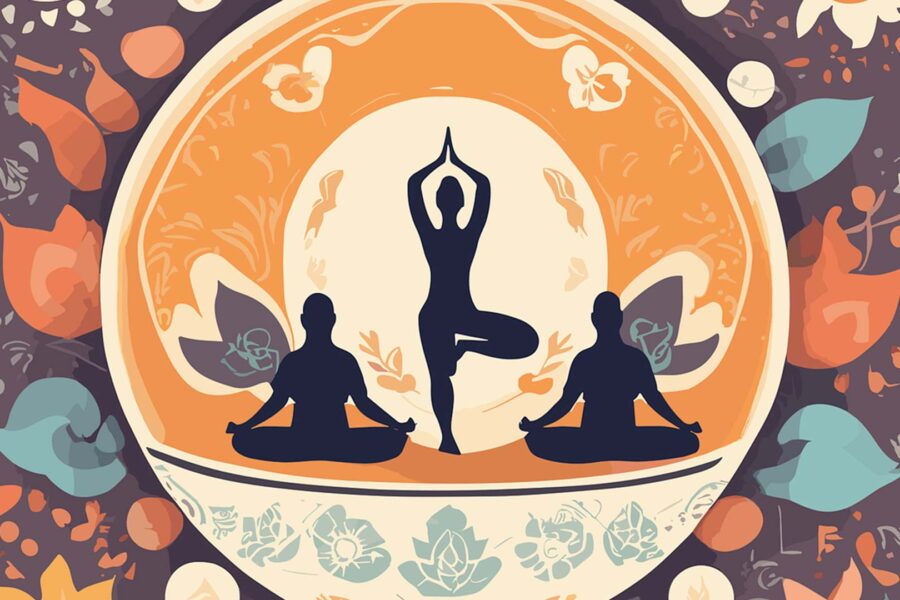
Quando si parla di testi della tradizione Hatha, di solito si menzionano la «Siva Samhita», la «Gheranda Samhita» e l’«Hatha Yoga Pradipika». Ma nelle biblioteche indiane giacciono migliaia e migliaia di manoscritti in attesa di essere tradotti. Gli esperti sono pochi e quindi ci vuole tempo. Da poco, per esempio, è stato scoperto e tradotto un altro testo, l'«Amṛtasiddhi», tradotto da James Mallinson, e a sua volta tradotto in italiano dalla nostra Amalia Cornale





